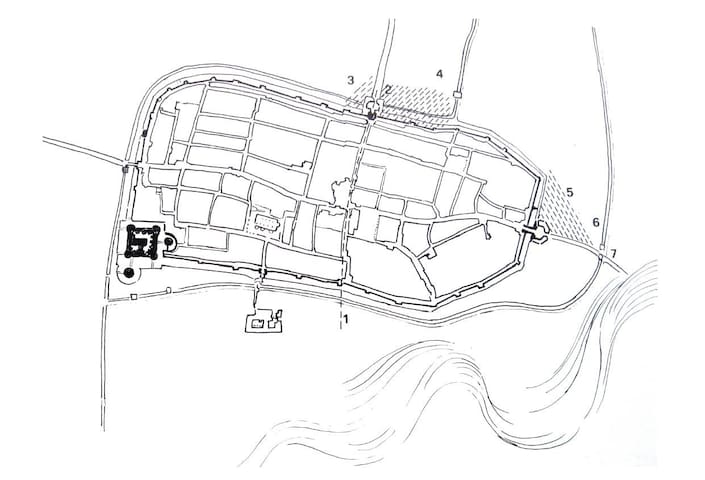Canale dei mulini
Il Canale dei Molini di Imola e Massalombarda è un corso d’acqua totalmente artificiale che prende il via alla chiusa di Codrignano, nove chilometri sopra Imola, attraversa i territori di Imola, Mordano e Massalombarda per poi rientrare nel Santerno al passo Regina (in località Massalombarda) grazie ad un sistema di chiuse che si aprono utilizzando la sola forza dell’acqua, dette “porte vinciane” dal nome del loro inventore Leonardo da Vinci. Di impianto medievale, il canale assunse grande importanza con la diffusione lungo il suo corso di numerosi molini. Sul suo corso, all’altezza della diga di Codrignano, si trova la “casa di guardia”, nata per controllare il corso del canale stesso e per fornire energia idraulica agli impianti molitori e alla centralina idroelettrica adiacente, che consente di sfruttare l'acqua per ottenere energia pulita e rinnovabile
Le sue prime tracce risalgono intorno all’anno Mille; è, molto probabilmente, il più antico manufatto a carattere economico esistente sul territorio imolese che abbia continuato ad operare nei secoli senza soluzione di continuità.
Il canale dei mulini di Imola (Canale dei Molini di Imola) è secolare; prima che sul canale venissero costruiti i mulini, le sue acque erano solcate da imbarcazioni che trasportavano merci.
Il canale fu probabilmente costruito dai romani e successivamente ristrutturato dai monaci benedettini nel VI secolo.
A nord di Imola, infatti, il canale è collegato con l'attuale via Selice, che in origine faceva parte dei secoli romani (centurie, la struttura stradale a griglia realizzata dai romani).
Oggi il canale nasce dal fiume Santerno, 9 km sopra Imola, in località Chiusa; corre quasi parallela al fiume fino a Imola, qui si dirama in due tronconi, che poi si uniscono. Il canale attraversa Massa Lombarda, San Patrizio, Conselice e Lavezzola; è lungo circa 40 km.
Il canale ha una funzione industriale e agricola; il primo è collegato a circa 16 mulini per cereali (per lo più da grano) ancora oggi funzionanti, il secondo è rappresentato dalla sua finalità irrigua, che ha assunto progressivamente maggiore importanza per gli agricoltori locali. Il canale ha anche un ruolo naturalistico e paesaggistico molto importante, grazie al suo ecosistema, ai suoi itinerari ciclopedonali e alla varietà di antiche costruzioni che si trovano lungo le sue sponde, come i mulini per cereali, zucchero e carta.
Tesori (perduti) di una terra: il Canale dei molini di Imola
Il Canale dei molini di Imola è un’opera idraulica millenaria lunga circa 40km che attraversa tutta la pianura imolese, in direzione sud-nord, fino a gettarsi nel fiume Reno. Progettato nell’Alto Medioevo dai benedettini del monastero di Santa Maria in Regola, utilizzando in parte il tracciato di un precedente canale romano, il canale artificiale scorre parallelamente al corso del fiume Santerno attraversando gli abitati di Bubano, Massa Lombarda, Conselice e Lavezzola. Costruito per l’alimentazione dei mulini e l’irrigazione dei campi, il Canale dei molini è la più antica opera pubblica esistente sul territorio imolese che abbia continuato ad operare nei secoli ininterrottamente.
La chiusa
Il Canale dei Molini attinge l’acqua dal fiume Santerno, a circa 6 km dall’abitato di Imola. L’opera viene citata per la prima volta in un rogito notarile del 1258. Nel Medioevo l’acqua del fiume era convogliata nel canale artificiale per mezzo di arginelli di sassi. Nell’800 fu deciso di costruire una diga sul fiume. La prima, costruita nel 1852, ebbe vita breve, poiché fu travolta da una piena sette anni dopo. Nel 1860 ne venne costruita una più solida, che resse per 90 anni. La chiusa attuale è stata costruita nel 1954 nei pressi della frazione Codrignano.
Il tracciato
Quando il canale raggiunge la città si sdoppia in due rami, che circondano completamente l’abitato. Il tratto urbano canale non è del tutto interrato: alcuni brevi tratti sono ancora visibili. Appena fuori dell’abitato, si riunisce in un unico corso e riappare a cielo aperto al fianco della Via provinciale Selice. Segue parallelamente il percorso della Selice per poi deviare ad est all’altezza di Bubano. Affiancata Bubano, il tracciato riprende la sua corsa verso nord. Dopo 4 km costeggia Massa Lombarda. Qui una parte delle acque sono deviate verso est, dove dopo pochi km ritornano nel fiume Santerno (al «passo Regina»).
L’altro ramo del canale, prosegue verso nord toccando, in successione, San Patrizio, Conselice e Lavezzola. Il canale si getta nel fiume Reno nei pressi del ponte detto “della Bastia” (Bastia Zaniolo).
Oggi il canale porta acqua solo fino a Massa Lombarda, dove un ramo alimenta il lavatoio pubblico. Un altro ramo si stacca dal corso principale prima dell’abitato e ritorna nel Santerno. Degli oltre venti mulini complessivamente attivi fino al Novecento, ne è rimasto tuttora funzionante soltanto uno, a Case Volta.
Storia
Prima fase – Dall’antichità fino alla fine del XIII secolo
Gli storici ritengono che, in tempi antichi, il Canale partisse da Imola (in tempi romani Forum Cornelii) e seguisse un percorso rettilineo fiancheggiante il cardo romano (oggi Via Selice) per terminare in un porto costruito sul limitare delle valli acquitrinose che costituivano il sistema lagunare della Valle Padusa. Si calcola che la via romana fosse lunga 12 miglia.
Il canale era probabilmente utilizzato come via d’acqua di collegamento tra Forum Cornelii ed il porto. Ancora nell’Alto Medioevo, prima che lungo il suo corso fossero installati i mulini che poi gli diedero il nome, il canale fungeva da idrovia per il trasporto delle merci: lo solcavano piccole imbarcazioni che portavano grano e cereali. Serviva anche per alimentare le acque del fossato a protezione delle mura di Imola.
Seconda fase – Dal 1300 ai nostri giorni
Con l’impianto dei primi mulini, all’altezza di Case Volta fu realizzata una prima deviazione verso est, allo scopo di costruire due nuovi mulini in direzione Bubano. Con la venuta degli Estensi in Romagna (dal 1440 al 1598) il percorso del Canale cambiò nuovamente. Fu realizzato il proseguimento verso nord per raggiungere i centri abitati della Romandiola: Massa Lombarda, San Patrizio e Conselice. Nei secoli successivi l’acqua del canale ha servito da supporto allo sviluppo dell’artigianato.
Gli utilizzi principali dei canali erano:
- molitura: lungo il suo corso vennero costruiti oltre venti mulini;
- irrigazione: il territorio coltivato ad orto, che interessava una vasta area, era irrigato con l’acqua del canale.
- In più, nel tempo si erano estese le risaie;
- i brillatoi per la lavorazione del riso funzionavano ad acqua;
- energia idraulica per varie lavorazioni manifatturiere: il primo stabilimento imolese di produzione delle ceramiche, in Via Quaini, così come la fornace Gardelli, la più antica, beneficiarono della presa d’acqua per l’impasto del materiale;
- lavatura dei panni nei lavatoi, sia pubblici e privati, di ospedali e conventi. Il più importante, tuttora esistente, si trova in Viale Saffi. Era detto “sciacquatoio” ed è riportato anche nella mappa di Imola di Leonardo da Vinci;
- lavorazione della canapa;
- scolatura ed espurgo delle immondizie: le concerie, le tintorie e il macello pubblico usufruirono di chiaviche lungo il canale per la pulizia dei locali.
Nel 1940 si è costituito il “Consorzio utenti del Canale di Imola e Massa Lombarda” (oggi Consorzio degli utenti del Canale dei molini). Oggi il canale dei molini alimenta i bacini di Bubano, dove l’acqua viene utilizzata per alimentare l’acquedotto industriale e inviata nei comuni vicini (dove viene potabilizzata). Il canale inoltre viene utilizzato per irrigare le aziende agricole del comprensorio di Imola e di Massa Lombarda. Nella frazione Codrignano è presente inoltre, in coincidenza con la presa del canale dei mulini dal fiume Santerno, una piccola centrale idroelettrica, che produce energia pulita e rinnovabile.
La navigazione fluviale tra Portus Caput Silicis e Forum Cornelii in eta romana
L’evoluzione storica del centro abitato di Imola è vincolata fortemente al corso d’acqua su cui sorge, il Santerno. I corsi d’acqua vanno soggetti a fenomeni di sovralluvionamento o a fenomeni di erosione a seconda del variare della piovosità nell’ambito dei loro bacini imbriferi e dei quantitativi di materiale solido che vengono immersi nelle loro correnti.
Durante una fase climatica di piovosità avviene un innalzamento degli alvei fluviali in quanto la corrente d’acqua non riesce a trasportare tutto il materiale che viene in essa riversato. Con la deposizione alluvionale del materiale in eccesso si produce un cambiamento nel profilo di equilibrio con l’innalzamento del letto fluviale. In questo modo una qualunque struttura, sia un ponte, una necropoli, o una strada che si trovavano in una posizione rispetto al fiume, possiamo dire di sicurezza, ora possono essere soggette a inondazioni e allagamenti fino ad essere completamente distrutti o ricoperti con le nuove piene che comunque raggiungeranno un livello di esondazione maggiore di quelle precedenti (nel tempo).
Il fenomeno inverso si ha quando la quantità di materiale solido che giunge in un corso d’acqua in un certo tratto è inferiore alla sua capacità di trasporto. In tal caso il fiume entra in erosione ed abbassa il suo letto. Si forma così ai suoi lati un ripiano terrazzato entro il quale rimangono sepolte quelle strutture che erano state investite dai fenomeni di aggradazione. (Strahler, 1977)
Dall’età di quelle strutture antropiche sepolte e di quelle poi sorte sulla superficie dello stesso terrazzo fluviale si possono trarre informazioni per datare il ciclo climatico di piovosità e di conseguenza la fase di degrado ambientale indotto dal deterioramento climatico.
Nella valle del Santerno, tra Borgo Tossignano e Imola, si notano vari ordini di terrazzi fluviali, da quelli posti a quote più alte e quindi più antichi, come a Casalfiumanese, Codrignano e a Ponticelli, a quelli più recenti e posti a quote più basse come il terrazzo fluviale percorso dal “Canale dei Molini” a monte di Imola (Marabini, 1994).
Nel periodo romano, il Santerno tra Borgo Tossignano e Imola aveva più o meno un andamento molto simile dal punto di vista idrologico a quello conservatosi fino a metà del ventesimo secolo.
Tra il 300 a.C. e il 400 a.C. un periodo pendolare di ottimo climatico non aveva creato sovralluvionamenti importanti, ed il drenaggio, anche delle opere di bonifica era ottimale alla morfologia di quel territorio. Nonostante il ciclo climatico benevolo, di cui in genere aveva goduto il periodo romano, ci sono state alcune annate umide e di cospicue precipitazioni e inondazioni tra la seconda metà del I sec. a.C. e il 200 d.C. (Accorsi, 1982).
Negli ultimi anni sono stati completati numerosi studi sulle variazioni idrografiche dei fiumi appenninici tra cui anche il Santerno. Con l’incrementarsi in questo ultimo decennio di studi condotti sulla base di dati rilevati da fotografie aeree, lo studio di elementi geomorfologici, l’esame litostratigrafico dei sedimenti superficiali, ecc. sono emersi elementi che ci permettono di ricostruire l’andamento topografico dei paleoalvei. In passato si è molto discusso sulla origine e sull’ubicazione degli idronimi Santerno (Santernus) e Vatreno (Vatrenus) o Vaterno (Vaternus). Non era possibile stabilire se questi idronimi corrispondessero ad un unico corso d’acqua o facessero riferimento a diversi corsi fluviali.
Comunemente si è sempre creduto che l’idronimo Vatreno o Vaterno corrispondesse a Santerno e di conseguenza fossero riferibili ad un unico corso fluviale.
L’idronimo Vatrenus o Vaternus si trova in Plinio verso la seconda metà del I sec. d.C. nella sua descrizione corografica del delta del Po, il termine Santernus verrà citato poco più tardi da Frontino negli scritti fra il 88 e il 96 d.C. È plausibile pensare, come già accennato da altri autori, che stando a questi dati si abbia a che fare con due toponimi diversi (Gambi, 1949). Così Polibio precedentemente nel 150 a.C. aveva scritto che, presa la città di Trigaboli (Ferrara?) il Po si divideva in due rami denominati Padoa e Olana, identificati più tardi dagli studiosi del rinascimento con il Po di Primaro e il Po di Volano. In realtà il Po di Primaro è di più recente formazione e il ramo Padoa, detto da Plinio Padusa, va ricercato nelle tracce dei paleoalvei riemerse dopo la bonifica della valle del Mezzano, dove la città di Spina sembrerebbe essere sorta sulla riva sinistra di questo braccio del Po (Padusa o Messanico) in corrispondenza di una fossa che collegava questo ramo con quello più a nord, detto Olana.
Ad ogni modo, in epoca romana Spina era già decaduta per il protrarsi notevole della linea di costa. A valle della città di Spina dove questo ramo viene chiamato Spinetico, riceveva sulla destra, come riferisce Plinio, un importante corso d’acqua appenninico proveniente dal territorio di Imola con il nome di Vatreno.
Dopo questa immissione si originavano i quattro rami del delta del Po i cui nomi nel suo sbocco a mare venivano detti da Plinio da sud verso nord, foce Fossa Augusta, foce Eridano o Vatreno, foce Caprasia e foce Sagis.
Dalle tracce fluviali emerse durante i lavori di bonifica della valle di Mezzano si è accertato ormai che il Vatreno si collega verso mare con il ramo Spinetico e verso monte, nella zona tra Lavezzola e S. Biagio, con gli attuali fiumi appenninici Sillaro e Santerno (Veggiani, 1973). Agli inizi del VIII sec. d.C. dissesti idrologici crearono un nuovo ramo padano più a sud del ramo Padusa che asciugarono il precedente delta padano includendo il Vatreno stesso. Alcune ricerche nella zona tra Cotignola, Bagnacavallo, Russi, Traversara e Santerno, dove si suppone passasse in epoca romana il fiume Santerno o un ramo di esso, portano a confermare una persistenza di corsi d’acqua con il nome di Santerno fino al sec. XII (Pasquali, 1978).
In epoca romana il Santerno, dopo aver attraversato Imola e raggiunto la zona di S. Prospero, si divideva in due rami di cui uno, che conservava il nome di Santerno, si dirigeva verso Ravenna e l’altro, denominato Vaterno (Vatreno), si dirigeva a Mordano, Massa Lombarda, Conselice e Lavezzola nel delta padano.
Con il nome di Vatreno si indicava molto probabilmente anche il tratto di fiume nel territorio imolese a monte della confluenza con il Sillaro e non solo il tratto a valle di detta confluenza. Uno studio etimologico approfondito dei toponimi Santerno e Vaterno, di chiara origine etrusca, potrebbe portare ad ammettere che il cambio di suono da “sa” a “va” sia dovuto al diverso andamento dei due corsi d’acqua oppure che un termine dia rilevanza al corso principale d’acqua e l’altro a quello secondario (Veggiani, 1975).
La città romana che sorgeva sul Santerno. Forum Cornelii, vede compiuta la sua fisionomia urbanistica ben definita solo nel corso del primo secolo a.C., dovuta verosimilmente ad un pianificato intervento, proprio tra la guerra sociale e l’età sillana.
Una piena autonomia amministrativa e la gestione delle proprie risorse accelera in questo periodo il rinnovo architettonico e urbanistico della città che presumibilmente si concluderà in piena età augustea intorno agli inizi del I sec d.C.
L’antico assetto urbanistico della città a occidente e a nordest dell’antico cardo maximum, oggi riconducibile alla prosecuzione di via Appia su via Mazzini, appare riconoscibile quasi immediatamente agli occhi di tutti gli studiosi. Non accade lo stesso per il settore sud-est di questa importante via, dove rimane molto dubbia la sistemazione dell’area tutt’oggi disomogenea rispetto allo sviluppo più coerente del resto della città. L’assetto urbanistico stradale appare come una rievocazione del passaggio in città di un’ansa del fiume Vatrenus o Santernus in età romana.
Recenti ritrovamenti di età romana compresi nell’area che si sviluppa tra la chiesa di Santa Maria in Regola e via Mameli angolo via Valsalva, affiancati da altri ritrovamenti in via Quaini e nell’area dell’ex convento del Buon Pastore ripropongono nuove considerazioni utili per lo studio di quest’area urbana.
La presenza di depositi consistenti di ghiaie e sabbie ha fatto ritenere possibile che la zona indagata facesse parte del bacino del Santernus in età romana quindi è possibile che un’ansa del fiume potesse avvicinarsi in maniera molto sensibile all’abitato, quindi lecito ritenere che la città fosse collegata al territorio non solo dallo sviluppo stradale ma anche attraverso il Santernus probabilmente navigabile fin dall’abitato di Forum Cornelii (Curina 2000).
In questo senso il recente progetto di ristrutturazione e ripristino del vecchio mercato ortofrutticolo di Imola, consistente nella realizzazione di un nuovo parcheggio sotterraneo, che ha richiesto una serie d’indagini preventive di prospezione e di scavo archeologico, apporta nuovi dati sull’argomento e sulla navigabilità del fiume Santerno nell’antichità. Dall’indagine archeologica sono emerse una serie d’interessanti strutture di età romana e medievale. I rinvenimenti si collocano topograficamente circoscritti a sud dal canale rinascimentale, che attualmente scorre sotto terra, e a nord dalle strutture del mercato ortofrutticolo da poco in fase di recupero edilizio. Quindi l’area interessata si trova sul fronte meridionale dell’antico centro storico di Imola e in prossimità del bacino idrografico del Santerno. Inoltre significativi rinvenimenti della fine dell’800, e più recenti studi di carattere topografico, individuano, in questa zona una articolata viabilità extraurbana dell’antica città di Forum Cornelii.
La scoperta più interessante orbita intorno al ritrovamento di una strada e canale di età romana a cui si associano une strutture di ambito commerciale ritenute appartenenti ad una banchina per l’approdo portuario di piccole chiatte.
Si tratta in particolare di una via glareata in ghiaia e ciottoli fluviali, messa in luce per una lunghezza complessiva di 55 metri e una larghezza media di 6 metri compresi i resti delle due fondazioni murarie che scorrono perimetralmente ad ogni lato della strada per tutto il tratto rinvenuto. Il tracciato stradale diviso in due tratti presenta due diverse direzioni. Il primo tratto mantiene un orientamento sulla direttrice NW/SE per circa 21 metri impostandosi sull’asse N/S per altri 34 metri fino ai resti della banchina fluviale disposta perpendicolarmente.
La banchina costituita da una fondazione muraria in manubriati romani e ciottoli fluviali è stata costruita a filo con il margine della sponda sinistra del fossato romano, su un piccolo terrapieno di rinforzo per una lunghezza complessiva di circa 25 metri divisa in due tratti (uno di 10 metri vicino alla strada romana e un altro di 15 metri più spostato verso ovest). Tre travature lignee, ritrovate sulla sponda del canale, consolidavano il terreno ulteriormente.
Le due fondazioni perimetrali al tracciato stradale sono state realizzate in ciottoli fluviali frammisti ad argilla. In alcuni punti è possibile apprezzare tratti di base muraria in frammenti di tegole e mattoni sesquipedali, con pezzame laterizio ed argilla tra le alette.
Ci sono inoltre alcuni allargamenti delle fondazioni a semipilastro che s’interpretano come punti di appoggio per una probabile sovrastruttura lignea. La strada romana presenta almeno due tagli trasversali dovuti a due fossati praticati successivamente nel tempo, probabilmente in età tardoantica e quando la strada non era già più in uso. I due fossati scorrono paralleli e sono disposti ortogonalmente ad un terzo fossato, cronologicamente in fase.
All’interno della superficie rettangolare che racchiudono questi fossati sono state individuate numerose tracce di aratura. Inoltre sono presenti alcune buche di pillo riconducibili a strutture cronologicamente posteriori ai fossati tardoantichi. All’interno di una di queste buche è stato rinvenuto un frammento di pietra oliare e alcuni frammenti di ceramica grezza ad impasto ritenute altomedievali.
A circa 6 metri della strada e in corrispondenza con la apertura praticata sulla fondazione muraria è stato rinvenuto un pozzo. Dopo avere realizzato una sezione mediante il taglio diametrale della struttura si è potuto verificare la presenza di una incamiciatura in mattoni puteali. Stratigraficamente le strutture si trovano coperte da uno strato fortemente antropizzato.
Questo strato che potremmo definire come di “abbandono” va a colmare in modo deciso anche un fossato che scorre parallelamente ad est della strada per tutta la sua lunghezza. Il tutto a sua volta è sigillato da un potente strato alluvionale di argilla limosa di colore giallastro sul quale troviamo uno strato di frequentazione, probabilmente bassomedievale e rinascimentale. e un massiccio riporto di macerie fino al piano stradale attuale.
Tra il materiale recuperato sulla strada romana in fase di scavo, figurano 10 monete in bronzo, prevalentemente di età altoimperiale, numerosissimi frammenti di vetro, alcuni in pasta vitrea, frammenti di ceramica grigia a pareti sottili, frammenti di ceramica tipo “terra sigillata”, ceramica a vernice nera, frammenti d’anfora, alcune tessere isolale di opera musiva, strumenti metallici e altri in osso lavorato.
Sono stati rinvenuti inoltre numerosi frammenti di piombo, chiodi in ferro e ossa animali. Cronologicamente la strada romana è in uso tra la seconda meta del I sec. a.C. e la fine del II sec d.C. Lo strato di abbandono individuato, da quanto si desume dal materiale rinvenuto, si può collocale tra la seconda metà del III sec. d.C. e gli albori del IV sec. d.C.
Parallelamente e poco a nord del noto Canale dei Mulini è stato rinvenuto un fossato di età medioevale, di circa 5 metri di larghezza che deluisce con pendenza verso est. Il fossato, da quanto si desume dalla sequenza stratigrafica del terreno, esisteva già in epoca romana con circa lo stesso tracciato. Infatti il suolo di frequentazione di età romana è riconoscibile lungo tutto il perimetro dello scavo, questo anche all’interno del fossato dove si riscontra in sezione la reincisione di età medievale per renderlo ancora funzionale. Lungo le due sponde del fossato sono emerse alcune strutture.
Sulla sponda sinistra è stata rinvenuta la fondazione muraria di età romana che funge da banchina, sulla sponda destra compaiono strutture murarie ricollegabili ad almeno due fasi in età medievale.
La fondazione muraria di età romana, realizzata in ciottoli e mattoni sesquipedali coincide, come posizione e orientamento, con il limite della sponda sinistra del fossato. Sempre su questa sponda e in sovrapposizione a quelle romane per un breve tratto, sono state rinvenute alcune tracce di opera muraria in mattoni di età medievale. Queste sono da mettere senza dubbio in relazione con quelle riscontrate sulla sponda destra.
Sulla sponda destra sono stati rinvenuti gli elementi strutturali di età medievale di maggiore consistenza. Su questa sponda si è verificata la presenza di un secondo canale assieme ad opere murarie dì età medievale. Detto canale è stato individuato per un tratto di circa 10 metri nel punto esatto in cui faceva defluire le sue acque in quello principale. Alcune di queste strutture murarie sono da mettere in relazione ad una attività di tipo produttivo certamente legata alla forza motrice dell’acqua.
Presumibilmente la captazione dell’acqua dal fossato principale che era fatta convogliare attraverso opere murarie simili a quelle scoperte avveniva in una zona ancora più a monte dell’area ora prospettata Tra le strutture ritrovate di questo secondo canale, sono apparse due opere murarie opposte, ciascuna in ogni sponda, che lasciano presupporre dalla sua costruzione l’uso di elementi di chiusa per il controllo delle acque.
Cronologicamente ci sono almeno due fasi dal punto di vista costruttivo in età medioevale. La prima sembra fare riferimento al momento della reincisione del precedente fossato di età romana. È in questo momento che vengono erette le prime strutture murarie in materiale laterizio. In questa fase cronologicamente inquadrabile verso il tredicesimo secolo non sembra esistere ancora il secondo fossato. Tuttavia non si esclude a priori che qualche tipo di struttura d’indole produttiva non adoperasse direttamente le acque del fossato principale come forza motrice.
Successivamente viene realizzato il secondo canale, che come abbiamo detto presumibilmente captava e di nuovo riportava le acque sul fossato principale, permettendo indubbiamente un migliore controllo di esse. Lo studio approfondito sul terreno della sequenza stratigrafica delle sabbie e limi dei due canali in rapporto diretto alle strutture murarie rinvenute, ci permette di affermare la coesistenza funzionale nel tempo di entrambi fossati. Alcuni reperti ceramici individuati all’interno delle sabbie del secondo canale, tra cui diversi frammenti di ceramica faentina “arcaica”, ci procurano informazioni più precise sulla vita del fossato.
Inoltre di certo interesse risulta il ritrovamento di una sepoltura di età romana sulla sponda destra del fossato. La sepoltura è stata rinvenuta in un determinato punto fra il canale rinascimentale e il taglio di reincisione del fossato medievale su quello romano. La quota da cui parte il taglio della sepoltura è nettamente inferiore alla quota di taglio raggiunta dal fondo del canale rinascimentale, è quindi plausibile l’ipotesi di ritrovare sotto questo canale e oltre verso sud un’area di necropoli romana. Indicativo risulta l’orientamento della sepoltura sull’asse S/N e che coincide perpendicolarmente con la sponda destra del fossato romano La sepoltura corrisponde a una tomba “a cassa laterizia” con pareti in manubrati messi di taglio. La sepoltura di un soggetto giovane, probabilmente un bambino, non ha restituito alcun elemento del corredo funerario e lo scheletro trovato all’interno si presentava sconnesso ed incompleto.
In base a questi dati sono diverse le considerazioni che si possono fare riguardo la navigabilità sul fiume Santerno nell’antichità. La prima e più importante è che effettivamente, e ora esiste la certezza con un riscontro di tipo archeologico, ci troviamo davanti a strutture di tipo commerciale legale al trasporto fluviale che s’insinuano vicinissime all’antico abitato di Forum Cornelii, dove ritroviamo persino una viabilità di servizio che le collega al centro della città.
Oggi comunemente si è portati a credere che in epoca romana all’estremità nord della strada selciata (Selice) che collegava Forum Cornelii, con la Padusa, l’antica palude a sud del Po descritta da Plinio, sorgesse un piccolo insediamento nato intorno ad un porto il così chiamato portus Caput Silicis presso l’odierna Conselice. Purtroppo i dati allo stato attuale rimangono insufficienti e non apportano elementi concreti di conferma di tipo archeologico. E’ senz’altro un ipotesi da confermare. Il documento più antico che fa riferimento al porto di Conselice è un atto del vescovo Morando del 1084 (Gaddoni, 1912). Più tardi nel 1450 circa viene menzionato di nuovo da Flavio Biondo di Forlì nella sua “Italia illustrata”. Successivamente Fra Girolamo Bonoli nel 1732 fa riferimento ancora al porto di Conselice nella “Storia di Lugo ed Annessi” (Bonoli, 1732).
Il Cerchiari nel 1848 commenta in questo modo: “Si tiene però che fra Ilia ed il suo fiume vi durasse ancora per lungo tempo un lago od un seno paludoso, poiché la chiesa parrocchiale di S. Pietro in città (ora soppressa) eretta ove era il tempio di Venere, si chiama S. Pietro in Laguna; e si tiene che questo lago si estendesse che giungne fino alla parrocchia di chiusura così denominata a Plaudendo perché chiudeva la acque.
Sopra di esso terreno passa la via Selice, che diciamo nel principio della storia costrutta da Appio Claudio tutta di selci, cioè di trachite, in causa delle molte bellette, conduttrice al porto di Conselice, poco al di sotto di questo paese evvi una casa di proprietà del sig. Conte Francesco Massari chiamata ancora Porto Venere dal nome antico del Porto, presso la quale si sono trovati anche di recente muri sotto terra con grosse anelle di ferro alle quali legavansi le barche” (Cerchiari, 1848).
In questo contesto sembra lecito parlare del canale communis, ora chiamato dei Molini. Il canale che costeggia la via Selice è menzionato in molti passaggi di documenti del sec. XII (Gaddoni, 1912). Si è anche attribuito al canale una probabile origine romana e lo si considera funzionante al momento del trattato con Venezia del 1099 (Galli, 1955): l’esistenza di questo canale sembrerebbe essere stata una delle cause per cui si firmò. Sempre facendo riferimento ad un documento del secolo XII il Galassi riporta: “…Tanto più che, sempre con lo stesso atto, riesce a strappare al vescovo anche l’uso del porto di Caput Silicis (Conselice) e l’impegno a riaprire il canale navigabile su di un precedente tracciato che, probabilmente in età romana, collegava Imola al porto” (Galassi, 1984).
Ricollegandoci a quanto riportato fin qui e in particolare a quest’ultima considerazione, le strutture portuali trovate nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo di Imola, e in concreto il fossato su cui si affacciano le banchine Per il carico e lo scarico delle merci trasportate, si circoscrivono topograficamente nell’ambito di un corso d’acqua artificiale che s’imposta decisamente su un precedente corso d’acqua naturale probabilmente un’ansa del fiume Santerno, distante di un paio di metri dall’attuale Canale dei Molini e che seguendo lo stesso tracciato pressappoco collegava Forum Cornelii al porto di Caput Silicis. Come abbiamo illustrato precedentemente, su questo fossato romano, navigabile sono stati realizzati almeno due diverse reincisioni di ripristino e bonifica in età medievale. Quindi è plausibile l’ipotesi di una continuità topografica di sfruttamento nel tempo, cominciando a partire da un antico braccio secondario del Santerno che prosciugatosi è stato ripristinato in età romana e così successivamente, almeno fino al sec. XIII-XIV, momento in cui viene spostato leggermente verso sud nel percorso che attualmente conosciamo.
È dunque probabile che la pianura forocorneliense e più specificamente l’antico portus Caput Silicis fosse collegato attraverso una efficiente rete di percorsi fluviali canalizzati, che in età romana di regola integrarono quelli terrestri, alle strutture portuarie di recente scoperta presso l’antica città di Forum Cornelii seguendo presumibilmente un percorso non molto diverso da quello che oggi conserva il Canale dei Molini.
IL FORUM I CASTRA E LA CIVITAS
“In effetti nell’antichità il Vaternus risultava navigabile, per lo meno fino all’età tardo antica, come risulta dalla presenza di un porto, Caput Silice (Conselice), che fungeva da principale sede di attracco prima dell’area ravennate, e dalla presenza di un canale16 utilizzato anch’esso per il trasporto merci (che ad Imola in periodo medievale avrebbe assunto la denominazione di canale dei Molini di Imola).” […]
Così, può darsi, che il un canale artificiale fosse già stato costruito in epoca romana per l’irrigazione dei campi. Questo primitivo tracciato avrebbe costeggiato la via Selice, attraversando la pianura imolese in direzione sud-nord fino a gettarsi nel fiume Reno.”
“Nel 2002 durante i lavori di ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di Imola furono portati alla luce i resti di un canale artificiale navigabile, bordato di una struttura interpretata come un attracco per piccole imbarcazioni. A pochi metri è stata rinvenuta un’area destinata ad attività produttive e scambi commerciali. (Si rimanda, in merito a questo tema, alla pubblicazione di L. VIVOLI, Il canale dei Molini dalle origini al 1955, U.B.P. 1995).
L’esistenza di quest’opera idraulica, viene riconosciuta quale caratteristica fondamentale del territorio imolese, le cui sorti furono strettamente connesse all’andamento ed alla produzione dell’agricoltura locale, come facilmente si desume dal fatto che l’economia di Forum Cornelii si contrasse e poi decadde con la crisi dell’agricoltura.”
La prima rudimentale difesa di cui Imola, o perché no ancor prima l’antica Forum Cornelii, dovette dotarsi, fu il fossato. La costruzione di un canale artificiale che sei chilometri circa a sud dell’abitato partiva attingendo acqua dal Santerno è di origine romana. Si ritiene che in epoca romana il canale seguisse un percorso rettilineo fiancheggiante il cardo romano (oggi via Selice) per terminare in un porto costruito sul limitare delle valli acquitrinose che costituivano il sistema lagunare della valle Padusa (Padus era l’antico nome del Po).
Si calcola che la via romana fosse lunga 12 miglia. Il canale era probabilmente utilizzato come via d’acqua di collegamento tra Forum Cornelii ed il porto (Caput Silicis,cioè Conselice).
Nel corso degli ultimi secoli dell’Alto Medioevo, prima che lungo il suo corso fossero installati i mulini che poi gli diedero il nome, il canale fungeva quasi certamente da idrovia per il trasporto delle merci: lo solcavano piccole imbarcazioni che portavano prodotti agricoli da e verso la zona ravennate.
A testimoniarlo resta ciò che è scritto all’interno del già citato documento per mezzo del qual il vescovo Morando cede nel 1084 parte dei suoi diritti ai cittadini imolesi (Ch. Im. II, n. 731, p.306; originale in ASCI, Pergamene, mazzo I, n. 3), tra cui l’uso del suo porto di Conselice, dietro pagamento di quattro denari veneti per ciascuna nave, esluse quelle per ambascerie o destinate all’acquisto del pesce per il rifornimento cittadino.
Oltre a questo, si può citare il già menzionato trattato commerciale coi veneziani del 1099, in cui si trova la richiesta di parte veneziana ad un versamento per ciascuna nave imolese di dodici denari veronesi per il ripatico e due per il fondale (Ch. Im., II, n. 733, p. 311).
I mulini che gli diedero il nome risalgono al periodo basso medievale (XII sec.): ed il canale viene menzionato con questo nome solo a partire del 1251 (T. LAZZARI, a cura di, Libro Rosso. Il “Registrum comunis Ymole” dal 1239 con addizioni al 1269, Imola 2005, n. 86 (c.68 recto e verso ), pp. 137-138.), prima viene designato quale canale del Comune di Imola.
E’ in questo periodo che, mentre si affievoliva la sua funzione “navile” per trasporto merci e passeggeri, cresceva “di importanza quella di propulsore dei mulini su di esso costruiti, non più soltanto nella cerchia della città, ma anche lungo il suo corso nelle campagne”.
Molti dei mulini costruiti lungo il suo tracciato non appartenevano a privati ma, costituendo una tra le più vitali esigenze dei cittadini, erano stati edificati dal Comune e, solo in seguito, dati in gestione (affitto o enfiteusi) a privati cittadini. E’ appunto di mulini ubicati tra le acque e le vie che parla già un documento del 1146 (GADDONI, ZACCHERINI, Ch. Im., II, n. 567, p. 106.); si tratta di mulini ubicati presso le strade che costeggiavano le vie d’acqua.
Nel 1210 risulta essere stato fatto un accordo tra il podestà Mainardino degli Aldighieri ed i castrimolesi, a beneficio di questi ultimi, per la ricostruzione dei due mulini di castel d’Imola che erano stati distrutti. (Doc. in SAVIOLI, Annali Bolognesi, Bassano 1784-1795, vol. II, n. II, p. 307. Per la consultazione ci si è avvalsi della trascrizione in Mancini, Imola nel medioevo, vol.II tomo I, pp. 168-169.)
Nel 1271, a causa delle cattive condizioni in cui versavano le sponde del canale, il Consiglio Generale del Popolo deliberava di aggiungere agli Statuti una “riformagione” con cui obbligava i conduttori dei mulini, da Imola in giù, a provvedere alla manutenzione delle sponde a proprie spese per la parte corrispondente al tratto superiore di predetto canale, il Comune d’altra parte si impegnava nella manutenzione di quello che costituiva il tratto iniziale, dalla Chiusa presso il Santerno alle serraglie di S. Cristina.
Il canale dei Molini dal tratto iniziale della Chiusa giungeva nei pressi della città sul lato sud ovest (in vicinanza della Rocca ) e si biforcava alle serraglie di S. Cristina. A quel punto si divideva in due rami, uno che costeggiava tutto il lato sud in direzione est e l’altro che proseguiva verso nord e, giunto all’altezza dell’odierna via Carducci proseguiva verso est sul lato nord dell’abitato, fino alla via Selice, raggiunta la quale piegava, costeggiandola per poi deviare ad est all’altezza di Bubano. Affiancato Bubano, il tracciato riprende la sua corsa verso nord.
Dopo 4 km costeggia Massa Lombarda. Qui una parte delle acque sono deviate verso est, dove, dopo qualche chilometro, si reimmettono nel fiume Santerno (al “passo Regina”). L’altro ramo del canale, prosegue verso nord toccando, in successione, San Patrizio, Conselice e Lavezzola. Il canale si getta nel fiume Reno in prossimità del ponte “della Bastia” (Bastia Zaniolo).
Oggi il canale dei Molini confluisce ancora nel Reno, ma senza apporto d’acqua. Come questo canale, seguisse perfettamente il tracciato dell’abitato si può osservare nella figura che tenta di ricostruire la topografia di Imola sulla base di un processo del 1294.
Dopo il 1300 vennero impiantati nuovi mulini anche fuori le mura, ed il canale, all’altezza di Case Volta, fu deviato verso est, per portare energia in direzione di Bubano. Lungo il suo corso in età moderna vennero costruiti una ventina di mulini. In epoca basso medievale, oltre ad alimentare le acque del fossato cittadino servì quale mezzo d’irrigazione, come lavatoio pubblico e privato, di ospedali e conventi (Il più importante, tuttora esistente, si trova in Viale Saffi. Era detto “sciacquatoio” ed è riportato anche nella mappa di Imola elaborata da Leonardo da Vinci); fu anche sfruttato da attività artigianali come callegari, tintori e beccai i quali usufruirono di chiaviche lungo il canale per la pulizia dei locali.
Le sue acque alla fine del medioevo azionavano diversi mulini, tra i quali ben sette erano situati lungo il tracciato delle vecchie mura della città. Uno presso porta Alone nella zona ovest(citato in un doc. del 1271, ASCI, Pergamene, mazzo III, n. 135), uno in prossimità di porta Piolo, uno della Selice, uno presso S. Cristina , il così detto mulino degli Aldrovandi, probabilmente sito nelle vicinanze della contrada Aldrovandi e perciò nella zona sud est dell’abitato (menzionato in un doc. del 1289, ANI, Pergamene, mazzo I, n. 15), un mulino detto nuovo situato in corrispondenza della via Avicis è attestato del 1430 (ANI, Pergamene, mazzo VII, n. 48) ed un altro nella zona est denominato mulino vecchio.
Si fa presente che degli oltre venti mulini complessivamente attivi lungo il suo corso fino al Novecento, ne è rimasto tuttora funzionante soltanto uno, a Case Volta.
Consorzio Utenti Canale Mulini D'Imola E Massalombarda
56 Via CavourIl Canale dei Molini di Imola e Massalombarda è un corso d’acqua totalmente artificiale che prende il via alla chiusa di Codrignano, nove chilometri sopra Imola, attraversa i territori di Imola, Mordano e Massalombarda per poi rientrare nel Santerno al passo Regina (in località Massalombarda) grazie ad un sistema di chiuse che si aprono utilizzando la sola forza dell’acqua, dette “porte vinciane” dal nome del loro inventore Leonardo da Vinci. Di impianto medievale, il canale assunse grande importanza con la diffusione lungo il suo corso di numerosi molini. Sul suo corso, all’altezza della diga di Codrignano, si trova la “casa di guardia”, nata per controllare il corso del canale stesso e per fornire energia idraulica agli impianti molitori e alla centralina idroelettrica adiacente, che consente di sfruttare l'acqua per ottenere energia pulita e rinnovabile
Le sue prime tracce risalgono intorno all’anno Mille; è, molto probabilmente, il più antico manufatto a carattere economico esistente sul territorio imolese che abbia continuato ad operare nei secoli senza soluzione di continuità.
Il canale dei mulini di Imola (Canale dei Molini di Imola) è secolare; prima che sul canale venissero costruiti i mulini, le sue acque erano solcate da imbarcazioni che trasportavano merci.
Il canale fu probabilmente costruito dai romani e successivamente ristrutturato dai monaci benedettini nel VI secolo.
A nord di Imola, infatti, il canale è collegato con l'attuale via Selice, che in origine faceva parte dei secoli romani (centurie, la struttura stradale a griglia realizzata dai romani).
Oggi il canale nasce dal fiume Santerno, 9 km sopra Imola, in località Chiusa; corre quasi parallela al fiume fino a Imola, qui si dirama in due tronconi, che poi si uniscono. Il canale attraversa Massa Lombarda, San Patrizio, Conselice e Lavezzola; è lungo circa 40 km.
Il canale ha una funzione industriale e agricola; il primo è collegato a circa 16 mulini per cereali (per lo più da grano) ancora oggi funzionanti, il secondo è rappresentato dalla sua finalità irrigua, che ha assunto progressivamente maggiore importanza per gli agricoltori locali. Il canale ha anche un ruolo naturalistico e paesaggistico molto importante, grazie al suo ecosistema, ai suoi itinerari ciclopedonali e alla varietà di antiche costruzioni che si trovano lungo le sue sponde, come i mulini per cereali, zucchero e carta.
Tesori (perduti) di una terra: il Canale dei molini di Imola
Il Canale dei molini di Imola è un’opera idraulica millenaria lunga circa 40km che attraversa tutta la pianura imolese, in direzione sud-nord, fino a gettarsi nel fiume Reno. Progettato nell’Alto Medioevo dai benedettini del monastero di Santa Maria in Regola, utilizzando in parte il tracciato di un precedente canale romano, il canale artificiale scorre parallelamente al corso del fiume Santerno attraversando gli abitati di Bubano, Massa Lombarda, Conselice e Lavezzola. Costruito per l’alimentazione dei mulini e l’irrigazione dei campi, il Canale dei molini è la più antica opera pubblica esistente sul territorio imolese che abbia continuato ad operare nei secoli ininterrottamente.
La chiusa
Il Canale dei Molini attinge l’acqua dal fiume Santerno, a circa 6 km dall’abitato di Imola. L’opera viene citata per la prima volta in un rogito notarile del 1258. Nel Medioevo l’acqua del fiume era convogliata nel canale artificiale per mezzo di arginelli di sassi. Nell’800 fu deciso di costruire una diga sul fiume. La prima, costruita nel 1852, ebbe vita breve, poiché fu travolta da una piena sette anni dopo. Nel 1860 ne venne costruita una più solida, che resse per 90 anni. La chiusa attuale è stata costruita nel 1954 nei pressi della frazione Codrignano.
Il tracciato
Quando il canale raggiunge la città si sdoppia in due rami, che circondano completamente l’abitato. Il tratto urbano canale non è del tutto interrato: alcuni brevi tratti sono ancora visibili. Appena fuori dell’abitato, si riunisce in un unico corso e riappare a cielo aperto al fianco della Via provinciale Selice. Segue parallelamente il percorso della Selice per poi deviare ad est all’altezza di Bubano. Affiancata Bubano, il tracciato riprende la sua corsa verso nord. Dopo 4 km costeggia Massa Lombarda. Qui una parte delle acque sono deviate verso est, dove dopo pochi km ritornano nel fiume Santerno (al «passo Regina»).
L’altro ramo del canale, prosegue verso nord toccando, in successione, San Patrizio, Conselice e Lavezzola. Il canale si getta nel fiume Reno nei pressi del ponte detto “della Bastia” (Bastia Zaniolo).
Oggi il canale porta acqua solo fino a Massa Lombarda, dove un ramo alimenta il lavatoio pubblico. Un altro ramo si stacca dal corso principale prima dell’abitato e ritorna nel Santerno. Degli oltre venti mulini complessivamente attivi fino al Novecento, ne è rimasto tuttora funzionante soltanto uno, a Case Volta.
Storia
Prima fase – Dall’antichità fino alla fine del XIII secolo
Gli storici ritengono che, in tempi antichi, il Canale partisse da Imola (in tempi romani Forum Cornelii) e seguisse un percorso rettilineo fiancheggiante il cardo romano (oggi Via Selice) per terminare in un porto costruito sul limitare delle valli acquitrinose che costituivano il sistema lagunare della Valle Padusa. Si calcola che la via romana fosse lunga 12 miglia.
Il canale era probabilmente utilizzato come via d’acqua di collegamento tra Forum Cornelii ed il porto. Ancora nell’Alto Medioevo, prima che lungo il suo corso fossero installati i mulini che poi gli diedero il nome, il canale fungeva da idrovia per il trasporto delle merci: lo solcavano piccole imbarcazioni che portavano grano e cereali. Serviva anche per alimentare le acque del fossato a protezione delle mura di Imola.
Seconda fase – Dal 1300 ai nostri giorni
Con l’impianto dei primi mulini, all’altezza di Case Volta fu realizzata una prima deviazione verso est, allo scopo di costruire due nuovi mulini in direzione Bubano. Con la venuta degli Estensi in Romagna (dal 1440 al 1598) il percorso del Canale cambiò nuovamente. Fu realizzato il proseguimento verso nord per raggiungere i centri abitati della Romandiola: Massa Lombarda, San Patrizio e Conselice. Nei secoli successivi l’acqua del canale ha servito da supporto allo sviluppo dell’artigianato.
Gli utilizzi principali dei canali erano:
- molitura: lungo il suo corso vennero costruiti oltre venti mulini;
- irrigazione: il territorio coltivato ad orto, che interessava una vasta area, era irrigato con l’acqua del canale.
- In più, nel tempo si erano estese le risaie;
- i brillatoi per la lavorazione del riso funzionavano ad acqua;
- energia idraulica per varie lavorazioni manifatturiere: il primo stabilimento imolese di produzione delle ceramiche, in Via Quaini, così come la fornace Gardelli, la più antica, beneficiarono della presa d’acqua per l’impasto del materiale;
- lavatura dei panni nei lavatoi, sia pubblici e privati, di ospedali e conventi. Il più importante, tuttora esistente, si trova in Viale Saffi. Era detto “sciacquatoio” ed è riportato anche nella mappa di Imola di Leonardo da Vinci;
- lavorazione della canapa;
- scolatura ed espurgo delle immondizie: le concerie, le tintorie e il macello pubblico usufruirono di chiaviche lungo il canale per la pulizia dei locali.
Nel 1940 si è costituito il “Consorzio utenti del Canale di Imola e Massa Lombarda” (oggi Consorzio degli utenti del Canale dei molini). Oggi il canale dei molini alimenta i bacini di Bubano, dove l’acqua viene utilizzata per alimentare l’acquedotto industriale e inviata nei comuni vicini (dove viene potabilizzata). Il canale inoltre viene utilizzato per irrigare le aziende agricole del comprensorio di Imola e di Massa Lombarda. Nella frazione Codrignano è presente inoltre, in coincidenza con la presa del canale dei mulini dal fiume Santerno, una piccola centrale idroelettrica, che produce energia pulita e rinnovabile.
La navigazione fluviale tra Portus Caput Silicis e Forum Cornelii in eta romana
L’evoluzione storica del centro abitato di Imola è vincolata fortemente al corso d’acqua su cui sorge, il Santerno. I corsi d’acqua vanno soggetti a fenomeni di sovralluvionamento o a fenomeni di erosione a seconda del variare della piovosità nell’ambito dei loro bacini imbriferi e dei quantitativi di materiale solido che vengono immersi nelle loro correnti.
Durante una fase climatica di piovosità avviene un innalzamento degli alvei fluviali in quanto la corrente d’acqua non riesce a trasportare tutto il materiale che viene in essa riversato. Con la deposizione alluvionale del materiale in eccesso si produce un cambiamento nel profilo di equilibrio con l’innalzamento del letto fluviale. In questo modo una qualunque struttura, sia un ponte, una necropoli, o una strada che si trovavano in una posizione rispetto al fiume, possiamo dire di sicurezza, ora possono essere soggette a inondazioni e allagamenti fino ad essere completamente distrutti o ricoperti con le nuove piene che comunque raggiungeranno un livello di esondazione maggiore di quelle precedenti (nel tempo).
Il fenomeno inverso si ha quando la quantità di materiale solido che giunge in un corso d’acqua in un certo tratto è inferiore alla sua capacità di trasporto. In tal caso il fiume entra in erosione ed abbassa il suo letto. Si forma così ai suoi lati un ripiano terrazzato entro il quale rimangono sepolte quelle strutture che erano state investite dai fenomeni di aggradazione. (Strahler, 1977)
Dall’età di quelle strutture antropiche sepolte e di quelle poi sorte sulla superficie dello stesso terrazzo fluviale si possono trarre informazioni per datare il ciclo climatico di piovosità e di conseguenza la fase di degrado ambientale indotto dal deterioramento climatico.
Nella valle del Santerno, tra Borgo Tossignano e Imola, si notano vari ordini di terrazzi fluviali, da quelli posti a quote più alte e quindi più antichi, come a Casalfiumanese, Codrignano e a Ponticelli, a quelli più recenti e posti a quote più basse come il terrazzo fluviale percorso dal “Canale dei Molini” a monte di Imola (Marabini, 1994).
Nel periodo romano, il Santerno tra Borgo Tossignano e Imola aveva più o meno un andamento molto simile dal punto di vista idrologico a quello conservatosi fino a metà del ventesimo secolo.
Tra il 300 a.C. e il 400 a.C. un periodo pendolare di ottimo climatico non aveva creato sovralluvionamenti importanti, ed il drenaggio, anche delle opere di bonifica era ottimale alla morfologia di quel territorio. Nonostante il ciclo climatico benevolo, di cui in genere aveva goduto il periodo romano, ci sono state alcune annate umide e di cospicue precipitazioni e inondazioni tra la seconda metà del I sec. a.C. e il 200 d.C. (Accorsi, 1982).
Negli ultimi anni sono stati completati numerosi studi sulle variazioni idrografiche dei fiumi appenninici tra cui anche il Santerno. Con l’incrementarsi in questo ultimo decennio di studi condotti sulla base di dati rilevati da fotografie aeree, lo studio di elementi geomorfologici, l’esame litostratigrafico dei sedimenti superficiali, ecc. sono emersi elementi che ci permettono di ricostruire l’andamento topografico dei paleoalvei. In passato si è molto discusso sulla origine e sull’ubicazione degli idronimi Santerno (Santernus) e Vatreno (Vatrenus) o Vaterno (Vaternus). Non era possibile stabilire se questi idronimi corrispondessero ad un unico corso d’acqua o facessero riferimento a diversi corsi fluviali.
Comunemente si è sempre creduto che l’idronimo Vatreno o Vaterno corrispondesse a Santerno e di conseguenza fossero riferibili ad un unico corso fluviale.
L’idronimo Vatrenus o Vaternus si trova in Plinio verso la seconda metà del I sec. d.C. nella sua descrizione corografica del delta del Po, il termine Santernus verrà citato poco più tardi da Frontino negli scritti fra il 88 e il 96 d.C. È plausibile pensare, come già accennato da altri autori, che stando a questi dati si abbia a che fare con due toponimi diversi (Gambi, 1949). Così Polibio precedentemente nel 150 a.C. aveva scritto che, presa la città di Trigaboli (Ferrara?) il Po si divideva in due rami denominati Padoa e Olana, identificati più tardi dagli studiosi del rinascimento con il Po di Primaro e il Po di Volano. In realtà il Po di Primaro è di più recente formazione e il ramo Padoa, detto da Plinio Padusa, va ricercato nelle tracce dei paleoalvei riemerse dopo la bonifica della valle del Mezzano, dove la città di Spina sembrerebbe essere sorta sulla riva sinistra di questo braccio del Po (Padusa o Messanico) in corrispondenza di una fossa che collegava questo ramo con quello più a nord, detto Olana.
Ad ogni modo, in epoca romana Spina era già decaduta per il protrarsi notevole della linea di costa. A valle della città di Spina dove questo ramo viene chiamato Spinetico, riceveva sulla destra, come riferisce Plinio, un importante corso d’acqua appenninico proveniente dal territorio di Imola con il nome di Vatreno.
Dopo questa immissione si originavano i quattro rami del delta del Po i cui nomi nel suo sbocco a mare venivano detti da Plinio da sud verso nord, foce Fossa Augusta, foce Eridano o Vatreno, foce Caprasia e foce Sagis.
Dalle tracce fluviali emerse durante i lavori di bonifica della valle di Mezzano si è accertato ormai che il Vatreno si collega verso mare con il ramo Spinetico e verso monte, nella zona tra Lavezzola e S. Biagio, con gli attuali fiumi appenninici Sillaro e Santerno (Veggiani, 1973). Agli inizi del VIII sec. d.C. dissesti idrologici crearono un nuovo ramo padano più a sud del ramo Padusa che asciugarono il precedente delta padano includendo il Vatreno stesso. Alcune ricerche nella zona tra Cotignola, Bagnacavallo, Russi, Traversara e Santerno, dove si suppone passasse in epoca romana il fiume Santerno o un ramo di esso, portano a confermare una persistenza di corsi d’acqua con il nome di Santerno fino al sec. XII (Pasquali, 1978).
In epoca romana il Santerno, dopo aver attraversato Imola e raggiunto la zona di S. Prospero, si divideva in due rami di cui uno, che conservava il nome di Santerno, si dirigeva verso Ravenna e l’altro, denominato Vaterno (Vatreno), si dirigeva a Mordano, Massa Lombarda, Conselice e Lavezzola nel delta padano.
Con il nome di Vatreno si indicava molto probabilmente anche il tratto di fiume nel territorio imolese a monte della confluenza con il Sillaro e non solo il tratto a valle di detta confluenza. Uno studio etimologico approfondito dei toponimi Santerno e Vaterno, di chiara origine etrusca, potrebbe portare ad ammettere che il cambio di suono da “sa” a “va” sia dovuto al diverso andamento dei due corsi d’acqua oppure che un termine dia rilevanza al corso principale d’acqua e l’altro a quello secondario (Veggiani, 1975).
La città romana che sorgeva sul Santerno. Forum Cornelii, vede compiuta la sua fisionomia urbanistica ben definita solo nel corso del primo secolo a.C., dovuta verosimilmente ad un pianificato intervento, proprio tra la guerra sociale e l’età sillana.
Una piena autonomia amministrativa e la gestione delle proprie risorse accelera in questo periodo il rinnovo architettonico e urbanistico della città che presumibilmente si concluderà in piena età augustea intorno agli inizi del I sec d.C.
L’antico assetto urbanistico della città a occidente e a nordest dell’antico cardo maximum, oggi riconducibile alla prosecuzione di via Appia su via Mazzini, appare riconoscibile quasi immediatamente agli occhi di tutti gli studiosi. Non accade lo stesso per il settore sud-est di questa importante via, dove rimane molto dubbia la sistemazione dell’area tutt’oggi disomogenea rispetto allo sviluppo più coerente del resto della città. L’assetto urbanistico stradale appare come una rievocazione del passaggio in città di un’ansa del fiume Vatrenus o Santernus in età romana.
Recenti ritrovamenti di età romana compresi nell’area che si sviluppa tra la chiesa di Santa Maria in Regola e via Mameli angolo via Valsalva, affiancati da altri ritrovamenti in via Quaini e nell’area dell’ex convento del Buon Pastore ripropongono nuove considerazioni utili per lo studio di quest’area urbana.
La presenza di depositi consistenti di ghiaie e sabbie ha fatto ritenere possibile che la zona indagata facesse parte del bacino del Santernus in età romana quindi è possibile che un’ansa del fiume potesse avvicinarsi in maniera molto sensibile all’abitato, quindi lecito ritenere che la città fosse collegata al territorio non solo dallo sviluppo stradale ma anche attraverso il Santernus probabilmente navigabile fin dall’abitato di Forum Cornelii (Curina 2000).
In questo senso il recente progetto di ristrutturazione e ripristino del vecchio mercato ortofrutticolo di Imola, consistente nella realizzazione di un nuovo parcheggio sotterraneo, che ha richiesto una serie d’indagini preventive di prospezione e di scavo archeologico, apporta nuovi dati sull’argomento e sulla navigabilità del fiume Santerno nell’antichità. Dall’indagine archeologica sono emerse una serie d’interessanti strutture di età romana e medievale. I rinvenimenti si collocano topograficamente circoscritti a sud dal canale rinascimentale, che attualmente scorre sotto terra, e a nord dalle strutture del mercato ortofrutticolo da poco in fase di recupero edilizio. Quindi l’area interessata si trova sul fronte meridionale dell’antico centro storico di Imola e in prossimità del bacino idrografico del Santerno. Inoltre significativi rinvenimenti della fine dell’800, e più recenti studi di carattere topografico, individuano, in questa zona una articolata viabilità extraurbana dell’antica città di Forum Cornelii.
La scoperta più interessante orbita intorno al ritrovamento di una strada e canale di età romana a cui si associano une strutture di ambito commerciale ritenute appartenenti ad una banchina per l’approdo portuario di piccole chiatte.
Si tratta in particolare di una via glareata in ghiaia e ciottoli fluviali, messa in luce per una lunghezza complessiva di 55 metri e una larghezza media di 6 metri compresi i resti delle due fondazioni murarie che scorrono perimetralmente ad ogni lato della strada per tutto il tratto rinvenuto. Il tracciato stradale diviso in due tratti presenta due diverse direzioni. Il primo tratto mantiene un orientamento sulla direttrice NW/SE per circa 21 metri impostandosi sull’asse N/S per altri 34 metri fino ai resti della banchina fluviale disposta perpendicolarmente.
La banchina costituita da una fondazione muraria in manubriati romani e ciottoli fluviali è stata costruita a filo con il margine della sponda sinistra del fossato romano, su un piccolo terrapieno di rinforzo per una lunghezza complessiva di circa 25 metri divisa in due tratti (uno di 10 metri vicino alla strada romana e un altro di 15 metri più spostato verso ovest). Tre travature lignee, ritrovate sulla sponda del canale, consolidavano il terreno ulteriormente.
Le due fondazioni perimetrali al tracciato stradale sono state realizzate in ciottoli fluviali frammisti ad argilla. In alcuni punti è possibile apprezzare tratti di base muraria in frammenti di tegole e mattoni sesquipedali, con pezzame laterizio ed argilla tra le alette.
Ci sono inoltre alcuni allargamenti delle fondazioni a semipilastro che s’interpretano come punti di appoggio per una probabile sovrastruttura lignea. La strada romana presenta almeno due tagli trasversali dovuti a due fossati praticati successivamente nel tempo, probabilmente in età tardoantica e quando la strada non era già più in uso. I due fossati scorrono paralleli e sono disposti ortogonalmente ad un terzo fossato, cronologicamente in fase.
All’interno della superficie rettangolare che racchiudono questi fossati sono state individuate numerose tracce di aratura. Inoltre sono presenti alcune buche di pillo riconducibili a strutture cronologicamente posteriori ai fossati tardoantichi. All’interno di una di queste buche è stato rinvenuto un frammento di pietra oliare e alcuni frammenti di ceramica grezza ad impasto ritenute altomedievali.
A circa 6 metri della strada e in corrispondenza con la apertura praticata sulla fondazione muraria è stato rinvenuto un pozzo. Dopo avere realizzato una sezione mediante il taglio diametrale della struttura si è potuto verificare la presenza di una incamiciatura in mattoni puteali. Stratigraficamente le strutture si trovano coperte da uno strato fortemente antropizzato.
Questo strato che potremmo definire come di “abbandono” va a colmare in modo deciso anche un fossato che scorre parallelamente ad est della strada per tutta la sua lunghezza. Il tutto a sua volta è sigillato da un potente strato alluvionale di argilla limosa di colore giallastro sul quale troviamo uno strato di frequentazione, probabilmente bassomedievale e rinascimentale. e un massiccio riporto di macerie fino al piano stradale attuale.
Tra il materiale recuperato sulla strada romana in fase di scavo, figurano 10 monete in bronzo, prevalentemente di età altoimperiale, numerosissimi frammenti di vetro, alcuni in pasta vitrea, frammenti di ceramica grigia a pareti sottili, frammenti di ceramica tipo “terra sigillata”, ceramica a vernice nera, frammenti d’anfora, alcune tessere isolale di opera musiva, strumenti metallici e altri in osso lavorato.
Sono stati rinvenuti inoltre numerosi frammenti di piombo, chiodi in ferro e ossa animali. Cronologicamente la strada romana è in uso tra la seconda meta del I sec. a.C. e la fine del II sec d.C. Lo strato di abbandono individuato, da quanto si desume dal materiale rinvenuto, si può collocale tra la seconda metà del III sec. d.C. e gli albori del IV sec. d.C.
Parallelamente e poco a nord del noto Canale dei Mulini è stato rinvenuto un fossato di età medioevale, di circa 5 metri di larghezza che deluisce con pendenza verso est. Il fossato, da quanto si desume dalla sequenza stratigrafica del terreno, esisteva già in epoca romana con circa lo stesso tracciato. Infatti il suolo di frequentazione di età romana è riconoscibile lungo tutto il perimetro dello scavo, questo anche all’interno del fossato dove si riscontra in sezione la reincisione di età medievale per renderlo ancora funzionale. Lungo le due sponde del fossato sono emerse alcune strutture.
Sulla sponda sinistra è stata rinvenuta la fondazione muraria di età romana che funge da banchina, sulla sponda destra compaiono strutture murarie ricollegabili ad almeno due fasi in età medievale.
La fondazione muraria di età romana, realizzata in ciottoli e mattoni sesquipedali coincide, come posizione e orientamento, con il limite della sponda sinistra del fossato. Sempre su questa sponda e in sovrapposizione a quelle romane per un breve tratto, sono state rinvenute alcune tracce di opera muraria in mattoni di età medievale. Queste sono da mettere senza dubbio in relazione con quelle riscontrate sulla sponda destra.
Sulla sponda destra sono stati rinvenuti gli elementi strutturali di età medievale di maggiore consistenza. Su questa sponda si è verificata la presenza di un secondo canale assieme ad opere murarie dì età medievale. Detto canale è stato individuato per un tratto di circa 10 metri nel punto esatto in cui faceva defluire le sue acque in quello principale. Alcune di queste strutture murarie sono da mettere in relazione ad una attività di tipo produttivo certamente legata alla forza motrice dell’acqua.
Presumibilmente la captazione dell’acqua dal fossato principale che era fatta convogliare attraverso opere murarie simili a quelle scoperte avveniva in una zona ancora più a monte dell’area ora prospettata Tra le strutture ritrovate di questo secondo canale, sono apparse due opere murarie opposte, ciascuna in ogni sponda, che lasciano presupporre dalla sua costruzione l’uso di elementi di chiusa per il controllo delle acque.
Cronologicamente ci sono almeno due fasi dal punto di vista costruttivo in età medioevale. La prima sembra fare riferimento al momento della reincisione del precedente fossato di età romana. È in questo momento che vengono erette le prime strutture murarie in materiale laterizio. In questa fase cronologicamente inquadrabile verso il tredicesimo secolo non sembra esistere ancora il secondo fossato. Tuttavia non si esclude a priori che qualche tipo di struttura d’indole produttiva non adoperasse direttamente le acque del fossato principale come forza motrice.
Successivamente viene realizzato il secondo canale, che come abbiamo detto presumibilmente captava e di nuovo riportava le acque sul fossato principale, permettendo indubbiamente un migliore controllo di esse. Lo studio approfondito sul terreno della sequenza stratigrafica delle sabbie e limi dei due canali in rapporto diretto alle strutture murarie rinvenute, ci permette di affermare la coesistenza funzionale nel tempo di entrambi fossati. Alcuni reperti ceramici individuati all’interno delle sabbie del secondo canale, tra cui diversi frammenti di ceramica faentina “arcaica”, ci procurano informazioni più precise sulla vita del fossato.
Inoltre di certo interesse risulta il ritrovamento di una sepoltura di età romana sulla sponda destra del fossato. La sepoltura è stata rinvenuta in un determinato punto fra il canale rinascimentale e il taglio di reincisione del fossato medievale su quello romano. La quota da cui parte il taglio della sepoltura è nettamente inferiore alla quota di taglio raggiunta dal fondo del canale rinascimentale, è quindi plausibile l’ipotesi di ritrovare sotto questo canale e oltre verso sud un’area di necropoli romana. Indicativo risulta l’orientamento della sepoltura sull’asse S/N e che coincide perpendicolarmente con la sponda destra del fossato romano La sepoltura corrisponde a una tomba “a cassa laterizia” con pareti in manubrati messi di taglio. La sepoltura di un soggetto giovane, probabilmente un bambino, non ha restituito alcun elemento del corredo funerario e lo scheletro trovato all’interno si presentava sconnesso ed incompleto.
In base a questi dati sono diverse le considerazioni che si possono fare riguardo la navigabilità sul fiume Santerno nell’antichità. La prima e più importante è che effettivamente, e ora esiste la certezza con un riscontro di tipo archeologico, ci troviamo davanti a strutture di tipo commerciale legale al trasporto fluviale che s’insinuano vicinissime all’antico abitato di Forum Cornelii, dove ritroviamo persino una viabilità di servizio che le collega al centro della città.
Oggi comunemente si è portati a credere che in epoca romana all’estremità nord della strada selciata (Selice) che collegava Forum Cornelii, con la Padusa, l’antica palude a sud del Po descritta da Plinio, sorgesse un piccolo insediamento nato intorno ad un porto il così chiamato portus Caput Silicis presso l’odierna Conselice. Purtroppo i dati allo stato attuale rimangono insufficienti e non apportano elementi concreti di conferma di tipo archeologico. E’ senz’altro un ipotesi da confermare. Il documento più antico che fa riferimento al porto di Conselice è un atto del vescovo Morando del 1084 (Gaddoni, 1912). Più tardi nel 1450 circa viene menzionato di nuovo da Flavio Biondo di Forlì nella sua “Italia illustrata”. Successivamente Fra Girolamo Bonoli nel 1732 fa riferimento ancora al porto di Conselice nella “Storia di Lugo ed Annessi” (Bonoli, 1732).
Il Cerchiari nel 1848 commenta in questo modo: “Si tiene però che fra Ilia ed il suo fiume vi durasse ancora per lungo tempo un lago od un seno paludoso, poiché la chiesa parrocchiale di S. Pietro in città (ora soppressa) eretta ove era il tempio di Venere, si chiama S. Pietro in Laguna; e si tiene che questo lago si estendesse che giungne fino alla parrocchia di chiusura così denominata a Plaudendo perché chiudeva la acque.
Sopra di esso terreno passa la via Selice, che diciamo nel principio della storia costrutta da Appio Claudio tutta di selci, cioè di trachite, in causa delle molte bellette, conduttrice al porto di Conselice, poco al di sotto di questo paese evvi una casa di proprietà del sig. Conte Francesco Massari chiamata ancora Porto Venere dal nome antico del Porto, presso la quale si sono trovati anche di recente muri sotto terra con grosse anelle di ferro alle quali legavansi le barche” (Cerchiari, 1848).
In questo contesto sembra lecito parlare del canale communis, ora chiamato dei Molini. Il canale che costeggia la via Selice è menzionato in molti passaggi di documenti del sec. XII (Gaddoni, 1912). Si è anche attribuito al canale una probabile origine romana e lo si considera funzionante al momento del trattato con Venezia del 1099 (Galli, 1955): l’esistenza di questo canale sembrerebbe essere stata una delle cause per cui si firmò. Sempre facendo riferimento ad un documento del secolo XII il Galassi riporta: “…Tanto più che, sempre con lo stesso atto, riesce a strappare al vescovo anche l’uso del porto di Caput Silicis (Conselice) e l’impegno a riaprire il canale navigabile su di un precedente tracciato che, probabilmente in età romana, collegava Imola al porto” (Galassi, 1984).
Ricollegandoci a quanto riportato fin qui e in particolare a quest’ultima considerazione, le strutture portuali trovate nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo di Imola, e in concreto il fossato su cui si affacciano le banchine Per il carico e lo scarico delle merci trasportate, si circoscrivono topograficamente nell’ambito di un corso d’acqua artificiale che s’imposta decisamente su un precedente corso d’acqua naturale probabilmente un’ansa del fiume Santerno, distante di un paio di metri dall’attuale Canale dei Molini e che seguendo lo stesso tracciato pressappoco collegava Forum Cornelii al porto di Caput Silicis. Come abbiamo illustrato precedentemente, su questo fossato romano, navigabile sono stati realizzati almeno due diverse reincisioni di ripristino e bonifica in età medievale. Quindi è plausibile l’ipotesi di una continuità topografica di sfruttamento nel tempo, cominciando a partire da un antico braccio secondario del Santerno che prosciugatosi è stato ripristinato in età romana e così successivamente, almeno fino al sec. XIII-XIV, momento in cui viene spostato leggermente verso sud nel percorso che attualmente conosciamo.
È dunque probabile che la pianura forocorneliense e più specificamente l’antico portus Caput Silicis fosse collegato attraverso una efficiente rete di percorsi fluviali canalizzati, che in età romana di regola integrarono quelli terrestri, alle strutture portuarie di recente scoperta presso l’antica città di Forum Cornelii seguendo presumibilmente un percorso non molto diverso da quello che oggi conserva il Canale dei Molini.
IL FORUM I CASTRA E LA CIVITAS
“In effetti nell’antichità il Vaternus risultava navigabile, per lo meno fino all’età tardo antica, come risulta dalla presenza di un porto, Caput Silice (Conselice), che fungeva da principale sede di attracco prima dell’area ravennate, e dalla presenza di un canale16 utilizzato anch’esso per il trasporto merci (che ad Imola in periodo medievale avrebbe assunto la denominazione di canale dei Molini di Imola).” […]
Così, può darsi, che il un canale artificiale fosse già stato costruito in epoca romana per l’irrigazione dei campi. Questo primitivo tracciato avrebbe costeggiato la via Selice, attraversando la pianura imolese in direzione sud-nord fino a gettarsi nel fiume Reno.”
“Nel 2002 durante i lavori di ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di Imola furono portati alla luce i resti di un canale artificiale navigabile, bordato di una struttura interpretata come un attracco per piccole imbarcazioni. A pochi metri è stata rinvenuta un’area destinata ad attività produttive e scambi commerciali. (Si rimanda, in merito a questo tema, alla pubblicazione di L. VIVOLI, Il canale dei Molini dalle origini al 1955, U.B.P. 1995).
L’esistenza di quest’opera idraulica, viene riconosciuta quale caratteristica fondamentale del territorio imolese, le cui sorti furono strettamente connesse all’andamento ed alla produzione dell’agricoltura locale, come facilmente si desume dal fatto che l’economia di Forum Cornelii si contrasse e poi decadde con la crisi dell’agricoltura.”
La prima rudimentale difesa di cui Imola, o perché no ancor prima l’antica Forum Cornelii, dovette dotarsi, fu il fossato. La costruzione di un canale artificiale che sei chilometri circa a sud dell’abitato partiva attingendo acqua dal Santerno è di origine romana. Si ritiene che in epoca romana il canale seguisse un percorso rettilineo fiancheggiante il cardo romano (oggi via Selice) per terminare in un porto costruito sul limitare delle valli acquitrinose che costituivano il sistema lagunare della valle Padusa (Padus era l’antico nome del Po).
Si calcola che la via romana fosse lunga 12 miglia. Il canale era probabilmente utilizzato come via d’acqua di collegamento tra Forum Cornelii ed il porto (Caput Silicis,cioè Conselice).
Nel corso degli ultimi secoli dell’Alto Medioevo, prima che lungo il suo corso fossero installati i mulini che poi gli diedero il nome, il canale fungeva quasi certamente da idrovia per il trasporto delle merci: lo solcavano piccole imbarcazioni che portavano prodotti agricoli da e verso la zona ravennate.
A testimoniarlo resta ciò che è scritto all’interno del già citato documento per mezzo del qual il vescovo Morando cede nel 1084 parte dei suoi diritti ai cittadini imolesi (Ch. Im. II, n. 731, p.306; originale in ASCI, Pergamene, mazzo I, n. 3), tra cui l’uso del suo porto di Conselice, dietro pagamento di quattro denari veneti per ciascuna nave, esluse quelle per ambascerie o destinate all’acquisto del pesce per il rifornimento cittadino.
Oltre a questo, si può citare il già menzionato trattato commerciale coi veneziani del 1099, in cui si trova la richiesta di parte veneziana ad un versamento per ciascuna nave imolese di dodici denari veronesi per il ripatico e due per il fondale (Ch. Im., II, n. 733, p. 311).
I mulini che gli diedero il nome risalgono al periodo basso medievale (XII sec.): ed il canale viene menzionato con questo nome solo a partire del 1251 (T. LAZZARI, a cura di, Libro Rosso. Il “Registrum comunis Ymole” dal 1239 con addizioni al 1269, Imola 2005, n. 86 (c.68 recto e verso ), pp. 137-138.), prima viene designato quale canale del Comune di Imola.
E’ in questo periodo che, mentre si affievoliva la sua funzione “navile” per trasporto merci e passeggeri, cresceva “di importanza quella di propulsore dei mulini su di esso costruiti, non più soltanto nella cerchia della città, ma anche lungo il suo corso nelle campagne”.
Molti dei mulini costruiti lungo il suo tracciato non appartenevano a privati ma, costituendo una tra le più vitali esigenze dei cittadini, erano stati edificati dal Comune e, solo in seguito, dati in gestione (affitto o enfiteusi) a privati cittadini. E’ appunto di mulini ubicati tra le acque e le vie che parla già un documento del 1146 (GADDONI, ZACCHERINI, Ch. Im., II, n. 567, p. 106.); si tratta di mulini ubicati presso le strade che costeggiavano le vie d’acqua.
Nel 1210 risulta essere stato fatto un accordo tra il podestà Mainardino degli Aldighieri ed i castrimolesi, a beneficio di questi ultimi, per la ricostruzione dei due mulini di castel d’Imola che erano stati distrutti. (Doc. in SAVIOLI, Annali Bolognesi, Bassano 1784-1795, vol. II, n. II, p. 307. Per la consultazione ci si è avvalsi della trascrizione in Mancini, Imola nel medioevo, vol.II tomo I, pp. 168-169.)
Nel 1271, a causa delle cattive condizioni in cui versavano le sponde del canale, il Consiglio Generale del Popolo deliberava di aggiungere agli Statuti una “riformagione” con cui obbligava i conduttori dei mulini, da Imola in giù, a provvedere alla manutenzione delle sponde a proprie spese per la parte corrispondente al tratto superiore di predetto canale, il Comune d’altra parte si impegnava nella manutenzione di quello che costituiva il tratto iniziale, dalla Chiusa presso il Santerno alle serraglie di S. Cristina.
Il canale dei Molini dal tratto iniziale della Chiusa giungeva nei pressi della città sul lato sud ovest (in vicinanza della Rocca ) e si biforcava alle serraglie di S. Cristina. A quel punto si divideva in due rami, uno che costeggiava tutto il lato sud in direzione est e l’altro che proseguiva verso nord e, giunto all’altezza dell’odierna via Carducci proseguiva verso est sul lato nord dell’abitato, fino alla via Selice, raggiunta la quale piegava, costeggiandola per poi deviare ad est all’altezza di Bubano. Affiancato Bubano, il tracciato riprende la sua corsa verso nord.
Dopo 4 km costeggia Massa Lombarda. Qui una parte delle acque sono deviate verso est, dove, dopo qualche chilometro, si reimmettono nel fiume Santerno (al “passo Regina”). L’altro ramo del canale, prosegue verso nord toccando, in successione, San Patrizio, Conselice e Lavezzola. Il canale si getta nel fiume Reno in prossimità del ponte “della Bastia” (Bastia Zaniolo).
Oggi il canale dei Molini confluisce ancora nel Reno, ma senza apporto d’acqua. Come questo canale, seguisse perfettamente il tracciato dell’abitato si può osservare nella figura che tenta di ricostruire la topografia di Imola sulla base di un processo del 1294.
Dopo il 1300 vennero impiantati nuovi mulini anche fuori le mura, ed il canale, all’altezza di Case Volta, fu deviato verso est, per portare energia in direzione di Bubano. Lungo il suo corso in età moderna vennero costruiti una ventina di mulini. In epoca basso medievale, oltre ad alimentare le acque del fossato cittadino servì quale mezzo d’irrigazione, come lavatoio pubblico e privato, di ospedali e conventi (Il più importante, tuttora esistente, si trova in Viale Saffi. Era detto “sciacquatoio” ed è riportato anche nella mappa di Imola elaborata da Leonardo da Vinci); fu anche sfruttato da attività artigianali come callegari, tintori e beccai i quali usufruirono di chiaviche lungo il canale per la pulizia dei locali.
Le sue acque alla fine del medioevo azionavano diversi mulini, tra i quali ben sette erano situati lungo il tracciato delle vecchie mura della città. Uno presso porta Alone nella zona ovest(citato in un doc. del 1271, ASCI, Pergamene, mazzo III, n. 135), uno in prossimità di porta Piolo, uno della Selice, uno presso S. Cristina , il così detto mulino degli Aldrovandi, probabilmente sito nelle vicinanze della contrada Aldrovandi e perciò nella zona sud est dell’abitato (menzionato in un doc. del 1289, ANI, Pergamene, mazzo I, n. 15), un mulino detto nuovo situato in corrispondenza della via Avicis è attestato del 1430 (ANI, Pergamene, mazzo VII, n. 48) ed un altro nella zona est denominato mulino vecchio.
Si fa presente che degli oltre venti mulini complessivamente attivi lungo il suo corso fino al Novecento, ne è rimasto tuttora funzionante soltanto uno, a Case Volta.
Il canale dei Molini di Imola è un'opera idraulica lunga 42 km che attraversa tutta la pianura imolese, in direzione sud-nord, fino a confluire nel fiume Reno. Realizzato nel Medioevo dai benedettini del monastero di Santa Maria in Regola, utilizzando in parte il tracciato di un precedente canale romano, il canale artificiale attraversa gli abitati di Bubano, Massa Lombarda, Conselice e Lavezzola.
Costruito per l'alimentazione dei mulini e l'irrigazione dei campi, il canale dei Molini è la più antica opera pubblica esistente sul territorio imolese operativa ininterrottamente dalla fondazione. Oggi ha una funzione prevalentemente irrigua.
La chiusa
Il canale dei Molini attinge l'acqua dal fiume Santerno nelle colline sopra Imola, in territorio di Codrignano (6 km circa dall'abitato). L'opera viene citata per la prima volta in un rogito notarile del 1258. Nel Medioevo l'acqua del fiume era convogliata nel canale artificiale per mezzo di arginelli di sassi. Nell'800 fu deciso di costruire una diga sul fiume. La prima, costruita nel 1852, ebbe vita breve, poiché fu travolta da una piena sette anni dopo. Nel 1860 ne venne costruita una più solida, che resse per 90 anni (crollò in seguito a una piena eccezionale del Santerno nel 1951). La chiusa attuale è stata costruita nel 1954 nei pressi della frazione Codrignano.
Il tracciato
Quando il canale raggiunge la città, si sdoppia in due rami che circondano completamente l'abitato. Il tratto urbano del canale è quasi del tutto interrato, ma alcuni brevi tratti sono ancora visibili. Appena fuori dell'abitato, si riunisce in un unico corso e riappare a cielo aperto al fianco della via provinciale Selice. Segue parallelamente il percorso della Selice per poi deviare ad est all'altezza di Bubano. Affiancata Bubano, il tracciato riprende la sua corsa verso nord. Dopo 4 km costeggia Massa Lombarda. Qui una parte delle acque sono deviate verso est, dove dopo pochi km ritornano nel fiume Santerno (al «passo Regina»).
L'altro ramo del canale prosegue verso nord costeggiando sempre la via Selice. Lambisce, in successione, San Patrizio, Conselice e Lavezzola. In questo secondo tratto il suo alveo è sopraelevato rispetto alla campagna circostante. A causa dell'alveo sopraelevato furono sempre necessari i lavori di manutenzione poiché ogni fuoriuscita dell'acqua avrebbe messo fuori uso la strada. Originariamente, il canale si gettava nel fiume Reno. Dal XIX secolo il canale termina il suo corso più ad est, nei pressi del ponte detto “della Bastia”.
Oggi il canale porta acqua solo fino a Massa Lombarda, dove un ramo alimenta il lavatoio pubblico e un secondo ramo si stacca dal corso principale prima dell'abitato e ritorna nel Santerno. Nel tratto da Massa Lombarda a Lavezzola non scorre più acqua dagli anni novanta del XX secolo.
Degli oltre venti mulini complessivamente attivi fino al Novecento, ne è rimasto tuttora funzionante soltanto uno, a Case Volta.
I mulini
- Pila Cipolla (loc. Fabbrica)
- Linaro (loc. Linaro)
- Paroli (Via Paroli, Imola)
- Illione (Imola, lungo le vecchie mura)
- Santa Cristina (lungo le vecchie mura)
- Molinazzo (lungo le vecchie mura)
- Mulino Nuovo (lungo le vecchie mura)
- Molino Vecchio (lungo le vecchie mura)
- Appio (lungo le vecchie mura)
- Gualchiera (lungo le vecchie mura)
- Poiano (Imola, oltre la ferrovia)
- Sega (1,5 km dalla città)
- Maglio (2 km dalla città)
- Molino Rosso de’ Prati (oggi scomparso)
- Volta (l’unico ancora attivo e l’ultimo in comune d’Imola)
- Faelli (loc. Chiavica, oggi scomparso)
- Bubano
- Rossi (a Bubano)
- Figna Antonio (a Bubano)
- Massa (a Massa Lombarda)
- San Patrizio
- Piatesi (nel centro storico di Conselice)
- Bastia (nei pressi del punto in cui il canale confluisce nel Reno)
L'antica via d'acqua che collegava Imola alla Valle Padusa
Gli storici ritengono che, in tempi antichi, i romani avessero costruito un canale artificiale a fianco del kardo che collegava Forum Cornelii al porto lagunare posto sul limitare della valle Padusa.
Il canale, che seguiva un tracciato rettilineo di circa 12 miglia (25 km), fu probabilmente utilizzato come via d'acqua di collegamento tra Forum Cornelii ed il porto e favorì sicuramente la fondazione di un centro abitato attorno allo scalo, l'odierna Conselice [2]. Ancora nella tarda antichità, il canale fungeva da idrovia per il trasporto delle merci: lo solcavano piccole imbarcazioni che portavano grano e cereali destinati all'esportazione, in cambio di stoffe e spezie. Da Imola verso la Valle il trasporto era favorito dalla corrente; nel percorso inverso le merci dovevano essere trainate dagli animali da soma, i quali procedevano lungo gli argini [2]. L'opera serviva anche per alimentare le acque del fossato a protezione delle mura di Imola.
Il Canale dei molini
La costruzione dell'attuale infrastruttura è dovuta a un progetto dei monaci di Santa Maria in Regola volto a risanare il territorio che era stato abbandonato dopo le devastazioni e le guerre dei secc. VI e VII. Furono recuperati anche i tratti del canale romano all'epoca esistenti.
A partire dal XII secolo, lungo il suo corso furono installati i mulini che poi gli diedero il nome. Con l'impianto dei primi mulini, all'altezza di Case Volta fu realizzata una deviazione verso est, allo scopo di costruire due nuovi mulini in direzione Bubano. Originariamente di proprietà del vescovo di Imola, nel 1271 il controllo del canale passò ai proprietari dei mulini.
Con la venuta degli Estensi in Romagna (dal 1440 al 1598), il percorso del canale cambiò nuovamente. Fu realizzato il proseguimento verso nord per raggiungere i centri abitati della Romagna estense: Massa Lombarda, San Patrizio e Conselice. Il controllo delle acque di questo nuovo tratto fu affidato alla comunità di Massa Lombarda[11]. Tali centri entrarono in conflitto con Imola per il controllo della via d'acqua. Ciò fu determinato anche da fattori stagionali: in estate Imola sospendeva l'afflusso d'acqua. Ma così i contadini di Massa e Conselice non potevano irrigare. D'inverno invece l'acqua scorreva senza freni fino a Bubano: si lasciava che le acque esondassero ed allagassero la campagna massese. I cittadini di Massa Lombarda protestarono, ma inutilmente.
Si arrivò all'uso della forza. Durante l'inverno del 1592[12], i massesi bloccarono il canale subito dopo l'abitato di Bubano. Di conseguenza le acque si riversarono nelle campagne imolesi allagandole completamente. La risposta d'Imola non si fece attendere: appena venne la bella stagione fu realizzata una diversione del canale a settentrione di Bubano, al confine con Massa Lombarda (la zona delle Vallette, cioè delle terre allagate), facendo defluire le acque direttamente nel fiume Santerno. I massesi assassinarono il capomastro direttore dei lavori, il conte Orazio della Bordella (1593)[12]. Solamente dopo questo fatto di sangue si giunse ad un accordo: prima della diversione di 2,2 km verso il Santerno (che fu portata a termine nonostante l'omicidio) venne realizzata una chiusa . Tale chiusa, tuttora esistente, è chiamata “delle Vallette” (1603). Essa serve a regolamentare l'afflusso delle acque: a) del Canale dei molini nel suo tratto verso Massa Lombarda (e Conselice); b) del "diversivo" che riporta le acque eccedenti verso il Santerno[13]. Un canale artificiale già esistente, lo Scolo Zaniolo, che nasceva a San Prospero (poco a sud di Mordano) fu unito al canale massese detto Sgorba Vecchia (1604). Al nuovo Zaniolo fu affidato il compito di deviare fuori Massa Lombarda le acque eccedenti provenienti dall'imolese[14].
Nei secoli successivi gli usi dell'acqua del canale vennero diversificati. Oltre all'irrigazione, l'acqua servì da supporto allo sviluppo dell'artigianato. I suoi utilizzi principali divennero:
molitura: lungo il suo corso vennero costruiti oltre venti mulini;
irrigazione: il territorio coltivato ad orto, che interessava una vasta area, era irrigato con l'acqua del canale. In più, nel tempo si erano estese le risaie; i brillatoi per la lavorazione del riso funzionavano ad acqua;
energia idraulica per varie lavorazioni manifatturiere: il primo stabilimento imolese di produzione delle ceramiche, in via Quaini, così come la fornace Gardelli, la più antica, beneficiarono della presa d'acqua per l'impasto del materiale;
lavatura dei panni nei lavatoi, sia pubblici e privati, di ospedali e conventi. Il più importante, tuttora esistente, si trova in viale Saffi. Era detto "sciacquatoio" ed è riportato anche nella mappa di Imola di Leonardo da Vinci;
lavorazione della canapa;
scolatura ed espurgo delle immondizie: le concerie [15], le tintorie e il macello pubblico usufruirono di chiaviche lungo il canale per la pulizia dei locali.
Storicamente le congregazioni di gestione furono due: una a Imola e una a Massa Lombarda. La necessità di una razionalizzazione fece sì che nell'anno 1940 si unificassero nel "Consorzio utenti del Canale dei molini di Imola e Massa Lombarda"[16] (oggi "Consorzio degli utenti del canale dei Molini"). Nel 2010 fu celebrato il settantennale dello Statuto con la «Festa del Canale dei molini» a Imola. Da essa nacque, l'anno successivo, la prima edizione della rinnovata «Fiera agricola del Santerno», che l'amministrazione comunale ha collocato nell'ampia area di Sante Zennaro, dove si svolge tuttora.[13]
Oggi i maggiori introiti dell'infrastruttura provengono dall'uso acquedottistico[13]. Le acque del canale alimentano l'acquedotto industriale sito a Bubano e inoltre sono inviate nei comuni vicini (dove l'acqua viene potabilizzata grazie a un accordo con l'allora Ami, oggi Hera). Il volume di acqua interessato è di cinque milioni di metri cubi. Il canale inoltre viene utilizzato per irrigare le aziende agricole (quasi 300) nei comprensori di Imola e di Massa Lombarda. Gli argini del canale sono di proprietà degli agricoltori i cui fondi sono attraversati dalla via d'acqua. Nella seconda metà del XX secolo la portata d'acqua presso Imola era di 3.000 litri al secondo, scesa negli anni 2010 a 700-800 litri/secondo[17].
Infine, nella frazione Codrignano, in coincidenza con la presa del canale dei mulini dal fiume Santerno, è presente una piccola centrale idroelettrica, che sfrutta il salto d'acqua della diga per produrre energia pulita e rinnovabile.
note:
1) Sono esistiti in Romagna i seguenti canali dei molini: di Imola; di Castel Bolognese; di Faenza («Naviglio Zanelli»); Schiavonia e di Ravaldino (Forlì); canale Doria (Meldola); di Cesena; fossa Viserba e fossa Pàtara (nel comune di Rimini); di Santarcangelo; di Misano; del Conca; di Valle (presso il Conca). Cfr. A. Missiroli, Il pane progettato. Mugnai e mulini idraulici in Romagna in «Romagna arte e storia», 72, 2004, pp. 38-43.
2) a b c Claudia PANCINO, Il canale dei molini da San Patrizio alla Bastia, in Romagnola Romandiola. Lungo la Selice. Territorio e Storia, Lugo, Università Popolare di Romagna, pp. 79-94.
3) Detto anche «di Lone», il nome deriva da Porta d'Alone, la porta della città per chi veniva da Bologna.
4) Toponimo che indica un mulino a secco.
5) Posto lungo la via Selice, un'arteria cittadina a grande traffico, è riconoscibile poiché restringe la sede stradale in prossimità di un semaforo.
6) È stato demolito nell'aprile 2016.
7) Alla fine degli anni Sessanta, quando si avviò la costruzione dell'autostrada A14, si diffuse la voce che il casello di Imola sarebbe stato costruito di fronte a questo mulino. Immediatamente fu acquistato e poi trasformato in albergo. Ancora oggi l'hotel Molino Rosso è una delle strutture ricettive più note della città.
8) Non più funzionante ma così ben conservato che è stato dichiarato monumento nazionale.
9) Oggi il canale dei Molini confluisce ancora nel Reno, ma senza l'apporto di acqua, che viene trattenuta a Massa Lombarda.
10) Per la precisione, si legge «Porta Appia» e accanto compare la sigla "Mol.".
11) A. F. Babini, Dalla Bastia del Zaniolo alla Bastia di Ca’ di Lugo, Lavezzola, Santerno, 1959, pag. 292.
12) a b Mario Montanari, Dalle furibonde liti sull'acqua del canale con Imola, alla rivolta contro la tassa sul macinato..., in «Giornale di massa», maggio 2018, pag. 8.
13) a b c Marzio Giampieri, Canale dei mulini, patrimonio da (ri)scoprire, in Il Nuovo Diario-Messaggero, 19 luglio 2014.
14) Salite e discese di pianura, dal Ponte dei Ladri alla "guerra" delle Vallette... in «Giornale di massa» n. 10, ottobre 2019, inserto speciale. Da allora lo Scolo Zaniolo si affianca al Canale dei molini in zona Vallette e prosegue il suo corso verso nord fino ad entrare nel territorio di Conselice.
15) Dette anche callegherie, di esse è rimasta memoria in una strada del centro, Via Callegherie.
16) Decreto ministeriale del 5 aprile 1940, n° 2254; modificato con D.M. del 26 aprile 1949, n° 5435.
17) Stefano Salomoni, «Il Canale dei Mulini è una risorsa preziosa», ne «Il nuovo Diario-Messaggero», primo luglio 2021, p. 11.
Via Canale
Via CanaleIl canale dei Molini di Imola è un'opera idraulica lunga 42 km che attraversa tutta la pianura imolese, in direzione sud-nord, fino a confluire nel fiume Reno. Realizzato nel Medioevo dai benedettini del monastero di Santa Maria in Regola, utilizzando in parte il tracciato di un precedente canale romano, il canale artificiale attraversa gli abitati di Bubano, Massa Lombarda, Conselice e Lavezzola.
Costruito per l'alimentazione dei mulini e l'irrigazione dei campi, il canale dei Molini è la più antica opera pubblica esistente sul territorio imolese operativa ininterrottamente dalla fondazione. Oggi ha una funzione prevalentemente irrigua.
La chiusa
Il canale dei Molini attinge l'acqua dal fiume Santerno nelle colline sopra Imola, in territorio di Codrignano (6 km circa dall'abitato). L'opera viene citata per la prima volta in un rogito notarile del 1258. Nel Medioevo l'acqua del fiume era convogliata nel canale artificiale per mezzo di arginelli di sassi. Nell'800 fu deciso di costruire una diga sul fiume. La prima, costruita nel 1852, ebbe vita breve, poiché fu travolta da una piena sette anni dopo. Nel 1860 ne venne costruita una più solida, che resse per 90 anni (crollò in seguito a una piena eccezionale del Santerno nel 1951). La chiusa attuale è stata costruita nel 1954 nei pressi della frazione Codrignano.
Il tracciato
Quando il canale raggiunge la città, si sdoppia in due rami che circondano completamente l'abitato. Il tratto urbano del canale è quasi del tutto interrato, ma alcuni brevi tratti sono ancora visibili. Appena fuori dell'abitato, si riunisce in un unico corso e riappare a cielo aperto al fianco della via provinciale Selice. Segue parallelamente il percorso della Selice per poi deviare ad est all'altezza di Bubano. Affiancata Bubano, il tracciato riprende la sua corsa verso nord. Dopo 4 km costeggia Massa Lombarda. Qui una parte delle acque sono deviate verso est, dove dopo pochi km ritornano nel fiume Santerno (al «passo Regina»).
L'altro ramo del canale prosegue verso nord costeggiando sempre la via Selice. Lambisce, in successione, San Patrizio, Conselice e Lavezzola. In questo secondo tratto il suo alveo è sopraelevato rispetto alla campagna circostante. A causa dell'alveo sopraelevato furono sempre necessari i lavori di manutenzione poiché ogni fuoriuscita dell'acqua avrebbe messo fuori uso la strada. Originariamente, il canale si gettava nel fiume Reno. Dal XIX secolo il canale termina il suo corso più ad est, nei pressi del ponte detto “della Bastia”.
Oggi il canale porta acqua solo fino a Massa Lombarda, dove un ramo alimenta il lavatoio pubblico e un secondo ramo si stacca dal corso principale prima dell'abitato e ritorna nel Santerno. Nel tratto da Massa Lombarda a Lavezzola non scorre più acqua dagli anni novanta del XX secolo.
Degli oltre venti mulini complessivamente attivi fino al Novecento, ne è rimasto tuttora funzionante soltanto uno, a Case Volta.
I mulini
- Pila Cipolla (loc. Fabbrica)
- Linaro (loc. Linaro)
- Paroli (Via Paroli, Imola)
- Illione (Imola, lungo le vecchie mura)
- Santa Cristina (lungo le vecchie mura)
- Molinazzo (lungo le vecchie mura)
- Mulino Nuovo (lungo le vecchie mura)
- Molino Vecchio (lungo le vecchie mura)
- Appio (lungo le vecchie mura)
- Gualchiera (lungo le vecchie mura)
- Poiano (Imola, oltre la ferrovia)
- Sega (1,5 km dalla città)
- Maglio (2 km dalla città)
- Molino Rosso de’ Prati (oggi scomparso)
- Volta (l’unico ancora attivo e l’ultimo in comune d’Imola)
- Faelli (loc. Chiavica, oggi scomparso)
- Bubano
- Rossi (a Bubano)
- Figna Antonio (a Bubano)
- Massa (a Massa Lombarda)
- San Patrizio
- Piatesi (nel centro storico di Conselice)
- Bastia (nei pressi del punto in cui il canale confluisce nel Reno)
L'antica via d'acqua che collegava Imola alla Valle Padusa
Gli storici ritengono che, in tempi antichi, i romani avessero costruito un canale artificiale a fianco del kardo che collegava Forum Cornelii al porto lagunare posto sul limitare della valle Padusa.
Il canale, che seguiva un tracciato rettilineo di circa 12 miglia (25 km), fu probabilmente utilizzato come via d'acqua di collegamento tra Forum Cornelii ed il porto e favorì sicuramente la fondazione di un centro abitato attorno allo scalo, l'odierna Conselice [2]. Ancora nella tarda antichità, il canale fungeva da idrovia per il trasporto delle merci: lo solcavano piccole imbarcazioni che portavano grano e cereali destinati all'esportazione, in cambio di stoffe e spezie. Da Imola verso la Valle il trasporto era favorito dalla corrente; nel percorso inverso le merci dovevano essere trainate dagli animali da soma, i quali procedevano lungo gli argini [2]. L'opera serviva anche per alimentare le acque del fossato a protezione delle mura di Imola.
Il Canale dei molini
La costruzione dell'attuale infrastruttura è dovuta a un progetto dei monaci di Santa Maria in Regola volto a risanare il territorio che era stato abbandonato dopo le devastazioni e le guerre dei secc. VI e VII. Furono recuperati anche i tratti del canale romano all'epoca esistenti.
A partire dal XII secolo, lungo il suo corso furono installati i mulini che poi gli diedero il nome. Con l'impianto dei primi mulini, all'altezza di Case Volta fu realizzata una deviazione verso est, allo scopo di costruire due nuovi mulini in direzione Bubano. Originariamente di proprietà del vescovo di Imola, nel 1271 il controllo del canale passò ai proprietari dei mulini.
Con la venuta degli Estensi in Romagna (dal 1440 al 1598), il percorso del canale cambiò nuovamente. Fu realizzato il proseguimento verso nord per raggiungere i centri abitati della Romagna estense: Massa Lombarda, San Patrizio e Conselice. Il controllo delle acque di questo nuovo tratto fu affidato alla comunità di Massa Lombarda[11]. Tali centri entrarono in conflitto con Imola per il controllo della via d'acqua. Ciò fu determinato anche da fattori stagionali: in estate Imola sospendeva l'afflusso d'acqua. Ma così i contadini di Massa e Conselice non potevano irrigare. D'inverno invece l'acqua scorreva senza freni fino a Bubano: si lasciava che le acque esondassero ed allagassero la campagna massese. I cittadini di Massa Lombarda protestarono, ma inutilmente.
Si arrivò all'uso della forza. Durante l'inverno del 1592[12], i massesi bloccarono il canale subito dopo l'abitato di Bubano. Di conseguenza le acque si riversarono nelle campagne imolesi allagandole completamente. La risposta d'Imola non si fece attendere: appena venne la bella stagione fu realizzata una diversione del canale a settentrione di Bubano, al confine con Massa Lombarda (la zona delle Vallette, cioè delle terre allagate), facendo defluire le acque direttamente nel fiume Santerno. I massesi assassinarono il capomastro direttore dei lavori, il conte Orazio della Bordella (1593)[12]. Solamente dopo questo fatto di sangue si giunse ad un accordo: prima della diversione di 2,2 km verso il Santerno (che fu portata a termine nonostante l'omicidio) venne realizzata una chiusa . Tale chiusa, tuttora esistente, è chiamata “delle Vallette” (1603). Essa serve a regolamentare l'afflusso delle acque: a) del Canale dei molini nel suo tratto verso Massa Lombarda (e Conselice); b) del "diversivo" che riporta le acque eccedenti verso il Santerno[13]. Un canale artificiale già esistente, lo Scolo Zaniolo, che nasceva a San Prospero (poco a sud di Mordano) fu unito al canale massese detto Sgorba Vecchia (1604). Al nuovo Zaniolo fu affidato il compito di deviare fuori Massa Lombarda le acque eccedenti provenienti dall'imolese[14].
Nei secoli successivi gli usi dell'acqua del canale vennero diversificati. Oltre all'irrigazione, l'acqua servì da supporto allo sviluppo dell'artigianato. I suoi utilizzi principali divennero:
molitura: lungo il suo corso vennero costruiti oltre venti mulini;
irrigazione: il territorio coltivato ad orto, che interessava una vasta area, era irrigato con l'acqua del canale. In più, nel tempo si erano estese le risaie; i brillatoi per la lavorazione del riso funzionavano ad acqua;
energia idraulica per varie lavorazioni manifatturiere: il primo stabilimento imolese di produzione delle ceramiche, in via Quaini, così come la fornace Gardelli, la più antica, beneficiarono della presa d'acqua per l'impasto del materiale;
lavatura dei panni nei lavatoi, sia pubblici e privati, di ospedali e conventi. Il più importante, tuttora esistente, si trova in viale Saffi. Era detto "sciacquatoio" ed è riportato anche nella mappa di Imola di Leonardo da Vinci;
lavorazione della canapa;
scolatura ed espurgo delle immondizie: le concerie [15], le tintorie e il macello pubblico usufruirono di chiaviche lungo il canale per la pulizia dei locali.
Storicamente le congregazioni di gestione furono due: una a Imola e una a Massa Lombarda. La necessità di una razionalizzazione fece sì che nell'anno 1940 si unificassero nel "Consorzio utenti del Canale dei molini di Imola e Massa Lombarda"[16] (oggi "Consorzio degli utenti del canale dei Molini"). Nel 2010 fu celebrato il settantennale dello Statuto con la «Festa del Canale dei molini» a Imola. Da essa nacque, l'anno successivo, la prima edizione della rinnovata «Fiera agricola del Santerno», che l'amministrazione comunale ha collocato nell'ampia area di Sante Zennaro, dove si svolge tuttora.[13]
Oggi i maggiori introiti dell'infrastruttura provengono dall'uso acquedottistico[13]. Le acque del canale alimentano l'acquedotto industriale sito a Bubano e inoltre sono inviate nei comuni vicini (dove l'acqua viene potabilizzata grazie a un accordo con l'allora Ami, oggi Hera). Il volume di acqua interessato è di cinque milioni di metri cubi. Il canale inoltre viene utilizzato per irrigare le aziende agricole (quasi 300) nei comprensori di Imola e di Massa Lombarda. Gli argini del canale sono di proprietà degli agricoltori i cui fondi sono attraversati dalla via d'acqua. Nella seconda metà del XX secolo la portata d'acqua presso Imola era di 3.000 litri al secondo, scesa negli anni 2010 a 700-800 litri/secondo[17].
Infine, nella frazione Codrignano, in coincidenza con la presa del canale dei mulini dal fiume Santerno, è presente una piccola centrale idroelettrica, che sfrutta il salto d'acqua della diga per produrre energia pulita e rinnovabile.
note:
1) Sono esistiti in Romagna i seguenti canali dei molini: di Imola; di Castel Bolognese; di Faenza («Naviglio Zanelli»); Schiavonia e di Ravaldino (Forlì); canale Doria (Meldola); di Cesena; fossa Viserba e fossa Pàtara (nel comune di Rimini); di Santarcangelo; di Misano; del Conca; di Valle (presso il Conca). Cfr. A. Missiroli, Il pane progettato. Mugnai e mulini idraulici in Romagna in «Romagna arte e storia», 72, 2004, pp. 38-43.
2) a b c Claudia PANCINO, Il canale dei molini da San Patrizio alla Bastia, in Romagnola Romandiola. Lungo la Selice. Territorio e Storia, Lugo, Università Popolare di Romagna, pp. 79-94.
3) Detto anche «di Lone», il nome deriva da Porta d'Alone, la porta della città per chi veniva da Bologna.
4) Toponimo che indica un mulino a secco.
5) Posto lungo la via Selice, un'arteria cittadina a grande traffico, è riconoscibile poiché restringe la sede stradale in prossimità di un semaforo.
6) È stato demolito nell'aprile 2016.
7) Alla fine degli anni Sessanta, quando si avviò la costruzione dell'autostrada A14, si diffuse la voce che il casello di Imola sarebbe stato costruito di fronte a questo mulino. Immediatamente fu acquistato e poi trasformato in albergo. Ancora oggi l'hotel Molino Rosso è una delle strutture ricettive più note della città.
8) Non più funzionante ma così ben conservato che è stato dichiarato monumento nazionale.
9) Oggi il canale dei Molini confluisce ancora nel Reno, ma senza l'apporto di acqua, che viene trattenuta a Massa Lombarda.
10) Per la precisione, si legge «Porta Appia» e accanto compare la sigla "Mol.".
11) A. F. Babini, Dalla Bastia del Zaniolo alla Bastia di Ca’ di Lugo, Lavezzola, Santerno, 1959, pag. 292.
12) a b Mario Montanari, Dalle furibonde liti sull'acqua del canale con Imola, alla rivolta contro la tassa sul macinato..., in «Giornale di massa», maggio 2018, pag. 8.
13) a b c Marzio Giampieri, Canale dei mulini, patrimonio da (ri)scoprire, in Il Nuovo Diario-Messaggero, 19 luglio 2014.
14) Salite e discese di pianura, dal Ponte dei Ladri alla "guerra" delle Vallette... in «Giornale di massa» n. 10, ottobre 2019, inserto speciale. Da allora lo Scolo Zaniolo si affianca al Canale dei molini in zona Vallette e prosegue il suo corso verso nord fino ad entrare nel territorio di Conselice.
15) Dette anche callegherie, di esse è rimasta memoria in una strada del centro, Via Callegherie.
16) Decreto ministeriale del 5 aprile 1940, n° 2254; modificato con D.M. del 26 aprile 1949, n° 5435.
17) Stefano Salomoni, «Il Canale dei Mulini è una risorsa preziosa», ne «Il nuovo Diario-Messaggero», primo luglio 2021, p. 11.
Lasciandosi alle spalle la chiusa e tornando verso il centro abitato di CastelBolognese si arriva davanti al Mulino di Scodellino: oltre a sorridere per la rima, ci sentiamo subito catapultati con la mente a quando i ritmi di vita erano decisamente più lenti, faticosi certo, ma sicuramente quando si apprezzavano a pieno le gioie del ritrovarsi in famiglia a condividere quello che si produceva con tanta fatica.
Non abbiamo data certa di costruzione di questo mulino, ma si pensa intorno agli ultimi anni del ‘300 (probabilmente 1396 o 1398).
Si tratta di un edificio importante per il nostro itinerario e per la storia del canale, in quanto conserva ancora praticamente inalterate tutte le caratteristiche medievali.
Gli unici interventi degni di nota riguardano infatti le modifiche realizzate negli anni ’20 e ’30, durante i quali vennero costruiti lo sfioratore e il canale secondario, che passa sotto al manto stradale facendo defluire aldilà della strada l’acqua in eccesso, e le modifiche effettuate alle ruote idrauliche.
Nel corso degli anni ’30 e ’40 quasi tutti i mulini ad acqua ancora in funzione furono modificati con moderne turbine, in grado di sfruttare al meglio la forza dell’acqua.
Il mulino, di proprietà del Comune di Castelbolognese fin dal 1489, è rimasto in funzione fino al 1982, ma è stato abitato dalla famiglia dell’ultimo mugnaio fino alla fine degli anni ’90.
PURTROPPO DA ALLORA, NONOSTANTE VARIE PROPOSTE, INIZIATIVE E PROGETTI PER IL RIPRISTINO E LA VALORIZZAZIONE DEL MANUFATTO FORMULATI DA ESPERTI E ASSOCIAZIONI LOCALI
le strutture sono rimaste pressoché abbandonate, subendo un lento ma inesorabile degrado.
Considerando le sue caratteristiche medievali, lo stato di conservazione delle macchine e dei locali, i progetti di ripristino funzionale del mulino sono certamente suggestivi, perchè darebbero la possibilità di creare un piccolo ma significativo”museo vivente”, una testimonianza delle tecniche idrauliche che si sono tramandate dal medioevo ad oggi e soprattutto di un mondo agricolo e produttivo che ha caratterizzato la pianura romagnola fino a pochi decenni fa.
Mulino Scodellino
7 Via CanaleLasciandosi alle spalle la chiusa e tornando verso il centro abitato di CastelBolognese si arriva davanti al Mulino di Scodellino: oltre a sorridere per la rima, ci sentiamo subito catapultati con la mente a quando i ritmi di vita erano decisamente più lenti, faticosi certo, ma sicuramente quando si apprezzavano a pieno le gioie del ritrovarsi in famiglia a condividere quello che si produceva con tanta fatica.
Non abbiamo data certa di costruzione di questo mulino, ma si pensa intorno agli ultimi anni del ‘300 (probabilmente 1396 o 1398).
Si tratta di un edificio importante per il nostro itinerario e per la storia del canale, in quanto conserva ancora praticamente inalterate tutte le caratteristiche medievali.
Gli unici interventi degni di nota riguardano infatti le modifiche realizzate negli anni ’20 e ’30, durante i quali vennero costruiti lo sfioratore e il canale secondario, che passa sotto al manto stradale facendo defluire aldilà della strada l’acqua in eccesso, e le modifiche effettuate alle ruote idrauliche.
Nel corso degli anni ’30 e ’40 quasi tutti i mulini ad acqua ancora in funzione furono modificati con moderne turbine, in grado di sfruttare al meglio la forza dell’acqua.
Il mulino, di proprietà del Comune di Castelbolognese fin dal 1489, è rimasto in funzione fino al 1982, ma è stato abitato dalla famiglia dell’ultimo mugnaio fino alla fine degli anni ’90.
PURTROPPO DA ALLORA, NONOSTANTE VARIE PROPOSTE, INIZIATIVE E PROGETTI PER IL RIPRISTINO E LA VALORIZZAZIONE DEL MANUFATTO FORMULATI DA ESPERTI E ASSOCIAZIONI LOCALI
le strutture sono rimaste pressoché abbandonate, subendo un lento ma inesorabile degrado.
Considerando le sue caratteristiche medievali, lo stato di conservazione delle macchine e dei locali, i progetti di ripristino funzionale del mulino sono certamente suggestivi, perchè darebbero la possibilità di creare un piccolo ma significativo”museo vivente”, una testimonianza delle tecniche idrauliche che si sono tramandate dal medioevo ad oggi e soprattutto di un mondo agricolo e produttivo che ha caratterizzato la pianura romagnola fino a pochi decenni fa.
Avanziamo per qualche Km più a nord e passiamo altri due mulini degni di nota: il Mulino di Solarolo e quello di Piani di Bagnara.
Il Mulino di Solarolo al suo interno oggi ospita una banca ed esercizi commerciali, ma all’esterno porta visibili alcuni particolari della vita produttiva del mulino e alcune strutture esterne come ad esempio le vecchie macine e il meccanismo di regolazione della paratoia che portava acqua al mulino.
Il Mulino Piani di Bagnara (detto anche Molinello Piani) fu realizzato nel 1468, a circa 2 km dall’abitato di Bagnara di Romagna: in seguito a ristrutturazioni ed ampliamenti realizzati nel corso degli anni, il “molinello” è uno degli edifici di maggiori dimensioni che sorgono lungo il canale, anche se ha da tempo abbandonato l’attività molitoria.
Comprato dalla Famiglia Muzzi dai Sig.ri Piani nei primi anni ’80 dopo che lo avevano abbandonato per oltre 20 anni, oggi si presenta come ristorante pizzeria, ma sono ancora ben visibili, sia all’interno che all’esterno del fabbricato, alcune strutture tipiche della sua funzione.
Molinello Piani
Avanziamo per qualche Km più a nord e passiamo altri due mulini degni di nota: il Mulino di Solarolo e quello di Piani di Bagnara.
Il Mulino di Solarolo al suo interno oggi ospita una banca ed esercizi commerciali, ma all’esterno porta visibili alcuni particolari della vita produttiva del mulino e alcune strutture esterne come ad esempio le vecchie macine e il meccanismo di regolazione della paratoia che portava acqua al mulino.
Il Mulino Piani di Bagnara (detto anche Molinello Piani) fu realizzato nel 1468, a circa 2 km dall’abitato di Bagnara di Romagna: in seguito a ristrutturazioni ed ampliamenti realizzati nel corso degli anni, il “molinello” è uno degli edifici di maggiori dimensioni che sorgono lungo il canale, anche se ha da tempo abbandonato l’attività molitoria.
Comprato dalla Famiglia Muzzi dai Sig.ri Piani nei primi anni ’80 dopo che lo avevano abbandonato per oltre 20 anni, oggi si presenta come ristorante pizzeria, ma sono ancora ben visibili, sia all’interno che all’esterno del fabbricato, alcune strutture tipiche della sua funzione.
LA PASSEGGIATA PROSEGUE PER ALTRI 4 KM CIRCONDATI DALLA RIGOGLIOSA VEGETAZIONE SU ENTRAMBI I LATI DEL CANALE
fino a raggiungere il confine con l’abitato di Lugo e il famoso ponte “delle lavandaie”.
Il ponte risalente al 1600, è detto “delle lavandaie” per via dei gradoni realizzati a nord, tutt’ora visibili, che arrivano fino all’acqua e che venivano utilizzati fino agli anni ?50 del secolo scorso dalle lavandaie per fare il bucato con molta fatica per sè e per le famiglie abbienti.
Il Ponte delle Lavandaie aveva un secondo parapetto (a sud) che venne abbattuto probabilmente durante la seconda guerra mondiale.
Ponte delle Lavandaie
LA PASSEGGIATA PROSEGUE PER ALTRI 4 KM CIRCONDATI DALLA RIGOGLIOSA VEGETAZIONE SU ENTRAMBI I LATI DEL CANALE
fino a raggiungere il confine con l’abitato di Lugo e il famoso ponte “delle lavandaie”.
Il ponte risalente al 1600, è detto “delle lavandaie” per via dei gradoni realizzati a nord, tutt’ora visibili, che arrivano fino all’acqua e che venivano utilizzati fino agli anni ?50 del secolo scorso dalle lavandaie per fare il bucato con molta fatica per sè e per le famiglie abbienti.
Il Ponte delle Lavandaie aveva un secondo parapetto (a sud) che venne abbattuto probabilmente durante la seconda guerra mondiale.
Se proseguiamo dal Ponte delle Lavandaia per circa 700 metri costeggiando il Canale dei Mulini su entrambe le sponde (sia a piedi che in bicicletta), concludiamo il nostro tour dove fino a pochi decenni fa sorgeva il Mulino Figna, in Via De’ Brozzi, realizzato nel 1561 e sopravvissuto con successivi ampliamenti e miglioramenti tecnici (turbine e impianti a cilindri), fino agli anni ?70 del secolo scorso.
Oggi purtroppo non esiste più, sostituito da costruzioni moderne e lo stesso tratto urbano del canale è tombato e quindi non visibile per alcune centinaia di metri.
Nei pressi del mulino erano inoltre presenti altri gradoni per lavare i panni, analogamente al ponte delle lavandaie, ma sono scomparsi anch’essi con la tombatura del canale.
I CANALI, I MULINI, LE CHIUSE CHE ATTRAVERSANO L’EMILIA ROMAGNA SONO TANTI, SIMBOLO DI UN’EREDITÀ DI UN PASSATO MOLTO RECENTE
e visitarli è un modo piacevole e inusuale per promuovere, valorizzare e tutelare la conoscenza storico/naturalistica del territorio: ci pensate quali possibilità potrebbe aprire un ripristino funzionale dei mulini e delle chiuse per realizzare attività di educazione ambientale che consentano di scoprire (o riscoprire) il legame tra attività proto-industriali e territorio?
Viale De' Brozzi
Viale De' BrozziSe proseguiamo dal Ponte delle Lavandaia per circa 700 metri costeggiando il Canale dei Mulini su entrambe le sponde (sia a piedi che in bicicletta), concludiamo il nostro tour dove fino a pochi decenni fa sorgeva il Mulino Figna, in Via De’ Brozzi, realizzato nel 1561 e sopravvissuto con successivi ampliamenti e miglioramenti tecnici (turbine e impianti a cilindri), fino agli anni ?70 del secolo scorso.
Oggi purtroppo non esiste più, sostituito da costruzioni moderne e lo stesso tratto urbano del canale è tombato e quindi non visibile per alcune centinaia di metri.
Nei pressi del mulino erano inoltre presenti altri gradoni per lavare i panni, analogamente al ponte delle lavandaie, ma sono scomparsi anch’essi con la tombatura del canale.
I CANALI, I MULINI, LE CHIUSE CHE ATTRAVERSANO L’EMILIA ROMAGNA SONO TANTI, SIMBOLO DI UN’EREDITÀ DI UN PASSATO MOLTO RECENTE
e visitarli è un modo piacevole e inusuale per promuovere, valorizzare e tutelare la conoscenza storico/naturalistica del territorio: ci pensate quali possibilità potrebbe aprire un ripristino funzionale dei mulini e delle chiuse per realizzare attività di educazione ambientale che consentano di scoprire (o riscoprire) il legame tra attività proto-industriali e territorio?
Canale Zaniolo
Il canale di "Destra Reno"
E Scól dagl'acqv cièri (per gli Alfonsinesi più brevemente "e Scol").
Utilizzando una documentazione di Mario Maginot Mazzotti, con le varie foto di Valeria Morelli e suo padre Guido, oltre al libro e le foto di T. Menzani.
Il canale in destra di Reno è un importante canale di bonifica della Romagna occidentale.
Deve il suo nome al fatto che scorre alla destra del fiume Reno, seguendone il percorso fino al mare Adriatico, mantenendosi alla distanza di circa 1 km. Buona parte del territorio scolante nel Canale in destra di Reno ricade in una minima parte del territorio in comune di Ravenna, cioè quella in sinistra Lamone (confine idraulico), da Conventello a Savarna fino a S.Alberto e Mandriole. Il più vasto territorio che gravita sul Destra Reno è rappresentato dall'intera bassa Romagna e da una parte della pianura faentina a valle della via Emilia.
Nasce dal canale di scolo Zaniolo, nel comune di Conselice.
Scorre in direzione ovest-est attraversando la parte settentrionale della provincia di Ravenna. Seguendo un corso quasi sempre rettilineo, dopo 37 km si getta nel mare Adriatico (in località Casal Borsetti), sfocia in mare utilizzando un tracciato tutto artificiale.
Prima di essere condotto a mare, il Lamone sfociava in Reno in località S.Alberto. Oggi sfocia 3 km a sud del canale.
Il fiume Reno scorre su un alveo pensile, quindi non può raccogliere le acque basse. Il canale artificiale è stato costruito allo scopo di raccogliere tutte le acque "basse" della provincia di Ravenna, è quindi il collettore generale della rete scolante del distretto di pianura, vale a dire è il canale in cui confluiscono, direttamente o indirettamente, per essere poi recapitate a mare, quasi tutte le acque dei cavi di bonifica presenti in un vasto territorio i cui confini coincidono, in massima parte, con il Reno a Nord, il Sillaro a Ovest, il Lamone a Est e la via Emilia a Sud. Si può ragionevolmente affermare che il Canale in destra di Reno è l'opera artificiale più importante della Provincia di Ravenna.
Il Canale di bonifica in destra di Reno ha una lunghezza di circa 37 Km e serve un bacino scolante di circa 75.000 ettari.
Ha origine al confine tra i Comuni di Argenta e Conselice, allo sbocco del collettore Zaniolo, in corrispondenza del manufatto denominato "Botte Selice", avente funzioni di opera di regimazione.
Sfocia a mare in località Casal Borsetti del Comune di Ravenna.
Via Canale a Destra
Via Canale a DestraIl canale in destra di Reno è un importante canale di bonifica della Romagna occidentale.
Deve il suo nome al fatto che scorre alla destra del fiume Reno, seguendone il percorso fino al mare Adriatico, mantenendosi alla distanza di circa 1 km. Buona parte del territorio scolante nel Canale in destra di Reno ricade in una minima parte del territorio in comune di Ravenna, cioè quella in sinistra Lamone (confine idraulico), da Conventello a Savarna fino a S.Alberto e Mandriole. Il più vasto territorio che gravita sul Destra Reno è rappresentato dall'intera bassa Romagna e da una parte della pianura faentina a valle della via Emilia.
Nasce dal canale di scolo Zaniolo, nel comune di Conselice.
Scorre in direzione ovest-est attraversando la parte settentrionale della provincia di Ravenna. Seguendo un corso quasi sempre rettilineo, dopo 37 km si getta nel mare Adriatico (in località Casal Borsetti), sfocia in mare utilizzando un tracciato tutto artificiale.
Prima di essere condotto a mare, il Lamone sfociava in Reno in località S.Alberto. Oggi sfocia 3 km a sud del canale.
Il fiume Reno scorre su un alveo pensile, quindi non può raccogliere le acque basse. Il canale artificiale è stato costruito allo scopo di raccogliere tutte le acque "basse" della provincia di Ravenna, è quindi il collettore generale della rete scolante del distretto di pianura, vale a dire è il canale in cui confluiscono, direttamente o indirettamente, per essere poi recapitate a mare, quasi tutte le acque dei cavi di bonifica presenti in un vasto territorio i cui confini coincidono, in massima parte, con il Reno a Nord, il Sillaro a Ovest, il Lamone a Est e la via Emilia a Sud. Si può ragionevolmente affermare che il Canale in destra di Reno è l'opera artificiale più importante della Provincia di Ravenna.
Il Canale di bonifica in destra di Reno ha una lunghezza di circa 37 Km e serve un bacino scolante di circa 75.000 ettari.
Ha origine al confine tra i Comuni di Argenta e Conselice, allo sbocco del collettore Zaniolo, in corrispondenza del manufatto denominato "Botte Selice", avente funzioni di opera di regimazione.
Sfocia a mare in località Casal Borsetti del Comune di Ravenna.
Mulini
“Chi va al mulino si infarina” recita un proverbio popolare. La morale è che, chiunque si imbatta in un’impresa difficile, dovrà accettarne poi tutte le conseguenze.
VIAGGIO TRA I MULINI DI ROMAGNA
Oggi partiamo proprio da questo modo di dire comune, per accompagnarvi in un viaggio tra i mulini di Romagna, ma soprattutto per porre attenzione ad uno dei prodotti che arriva quotidianamente sulle nostre tavole: la farina.
Pensando al mulino, la nostra mente ritorna a tempi lontani, quando il contatto con la natura e l’ambiente era la regola. A dire il vero, il mulino è uno strumento tipicamente meccanico, utilizzato ancora oggi, dal cui lavoro nascono eccellenti farine con precisi parametri di qualità e spesso certificate biologicamente.
Sapevate che in Romagna esistono mulini a pietra che producono ottime farine con grani antichi? Per chi ancora non li conosce e volesse servirsene, ecco qui l’occasione per un individuare quello più vicino.
Premilcuore
Nome: Mulino Mengozzi
Regione: Emilia-Romagna
Provincia: Forlì - Cesena
Comune: Premilcuore
Indirizzo: Fraz. Fiumicello
Tipologia: Acqua
Attività: Farina di castagne, cereali e mais
Proprietà: Privato
Info proprietà: Fam. Mengozzi
Stato: In funzione
Visitabile: Sì
Bibliografia:
Note storiche:
Mulino Mengozzi
Premilcuore
Nome: Mulino Mengozzi
Regione: Emilia-Romagna
Provincia: Forlì - Cesena
Comune: Premilcuore
Indirizzo: Fraz. Fiumicello
Tipologia: Acqua
Attività: Farina di castagne, cereali e mais
Proprietà: Privato
Info proprietà: Fam. Mengozzi
Stato: In funzione
Visitabile: Sì
Bibliografia:
Note storiche:
Premilcuore
Il molino Biondi è situato sul torrente Rabbi ed è raggiungibile percorrendo la S.S. 9 da Premilcuore in direzione Firenze. Il fabbricato, recentemente ristrutturato, il cui nucleo iniziale risale al 1500, è su tre piani ed è costruito sulla roccia. Il bottaccio alimenta due macine. Inoltre con un successivo salto, l’acqua alimenta un’altra macina più piccola. Attualmente è utilizzato solo a scopo didattico e dimostrativo.
Info logistiche e contatti
Molino Biondi di Castel dell’Alpe, Loc. Castel dell’Alpe, 25 - Premilcuore (FC
Molino Castel dell'Alpe
SP9terPremilcuore
Il molino Biondi è situato sul torrente Rabbi ed è raggiungibile percorrendo la S.S. 9 da Premilcuore in direzione Firenze. Il fabbricato, recentemente ristrutturato, il cui nucleo iniziale risale al 1500, è su tre piani ed è costruito sulla roccia. Il bottaccio alimenta due macine. Inoltre con un successivo salto, l’acqua alimenta un’altra macina più piccola. Attualmente è utilizzato solo a scopo didattico e dimostrativo.
Info logistiche e contatti
Molino Biondi di Castel dell’Alpe, Loc. Castel dell’Alpe, 25 - Premilcuore (FC
Cesena
Cominciamo dal Molino Maraldi, a pochi passi dal cuore della città di Cesena. Qui potrete acquistare una linea di farine macinate a pietra, genuine, nutrienti e lavorate davvero a regola d’arte.
Seconda tappa Predappio, comune in provincia di Forlì-Cesena. Qui, percorrendo via S. Martino in Avello, si raggiunge il Molino Conficoni Ilario. In cima alle colline, in un contesto incontaminato, il piccolo mulino a pietra offre un’ampia scelta di farine tra cui farro, frumento duro o tenero, grano saraceno, kamut, mais, orzo e svariate altre.
Stessa provincia, ma paese diverso quello che ospita Il Regno delle Upupe, azienda agricola biologica a San Paolo in Acquiliano, a Civitella di Romagna. A grande richiesta, segnalato dai lettori il Molino Stefano Pransani di Sogliano al Rubicone in provincia di Forlì-Cesena.
Molino Maraldi Maraldi Erika & C. Sas
11 Via Savio in San MicheleCesena
Cominciamo dal Molino Maraldi, a pochi passi dal cuore della città di Cesena. Qui potrete acquistare una linea di farine macinate a pietra, genuine, nutrienti e lavorate davvero a regola d’arte.
Seconda tappa Predappio, comune in provincia di Forlì-Cesena. Qui, percorrendo via S. Martino in Avello, si raggiunge il Molino Conficoni Ilario. In cima alle colline, in un contesto incontaminato, il piccolo mulino a pietra offre un’ampia scelta di farine tra cui farro, frumento duro o tenero, grano saraceno, kamut, mais, orzo e svariate altre.
Stessa provincia, ma paese diverso quello che ospita Il Regno delle Upupe, azienda agricola biologica a San Paolo in Acquiliano, a Civitella di Romagna. A grande richiesta, segnalato dai lettori il Molino Stefano Pransani di Sogliano al Rubicone in provincia di Forlì-Cesena.
Nome: Molino Benini
Regione: Emilia-Romagna
Provincia: Revenna
Comune: Ravenna
Indirizzo: Via Cella, 380 Santo Stefano
Tipologia: Industriale
Attività: Farina di cereali
Proprietà: Privato
Info proprietà: Il Molino Benini è immerso nella realtà rurale di un territorio da secoli vocato all’agricoltura e nello specifico alla coltivazione del grano. Il grano che maciniamo proviene proprio dal nostro territorio e la nostra filiera è cortissima, quasi a “CHILOMETRO ZERO”.
Stato: In funzione
Visitabile: Si
Ospitalità: Si
Bibliografia:
Note storiche: Nasce nel 1926 l’antico Molino storico sito in Santo Stefano, paese di campagna nelle immediate vicinanze di Ravenna; il molino si è sempre distinto per la qualità delle proprie farine. Una tradizione che va avanti da quasi un secolo, utilizzando solo grano romagnolo che viene macinato con una procedura che viene definita “macinazione lenta” in modo da preservare al massimo le qualità naturali del cereale. Il Molino Benini rifornisce i migliori pastifici, piadinerie, pasticcerie e pizzerie/ristoranti della Romagna. Oltre alla produzione e vendita di farina, il Molino Benini vende nello spaccio sito nella stessa struttura del mulino, le farine ma anche articoli da giardinaggio, mangimi per cani, gatti e volatili, vino, articoli per la casa, sementi, piante, fiori e granaglie.
Molino Benini Sas Di Ricci Luciano
380 Via CellaNome: Molino Benini
Regione: Emilia-Romagna
Provincia: Revenna
Comune: Ravenna
Indirizzo: Via Cella, 380 Santo Stefano
Tipologia: Industriale
Attività: Farina di cereali
Proprietà: Privato
Info proprietà: Il Molino Benini è immerso nella realtà rurale di un territorio da secoli vocato all’agricoltura e nello specifico alla coltivazione del grano. Il grano che maciniamo proviene proprio dal nostro territorio e la nostra filiera è cortissima, quasi a “CHILOMETRO ZERO”.
Stato: In funzione
Visitabile: Si
Ospitalità: Si
Bibliografia:
Note storiche: Nasce nel 1926 l’antico Molino storico sito in Santo Stefano, paese di campagna nelle immediate vicinanze di Ravenna; il molino si è sempre distinto per la qualità delle proprie farine. Una tradizione che va avanti da quasi un secolo, utilizzando solo grano romagnolo che viene macinato con una procedura che viene definita “macinazione lenta” in modo da preservare al massimo le qualità naturali del cereale. Il Molino Benini rifornisce i migliori pastifici, piadinerie, pasticcerie e pizzerie/ristoranti della Romagna. Oltre alla produzione e vendita di farina, il Molino Benini vende nello spaccio sito nella stessa struttura del mulino, le farine ma anche articoli da giardinaggio, mangimi per cani, gatti e volatili, vino, articoli per la casa, sementi, piante, fiori e granaglie.
Nome: Mulino Ronci
Regione: Emilia-Romagna
Provincia: Rimini
Comune: Pennabilli
Indirizzo: via Mulino Schieti, 23 Ponte Messa
Tipologia: Acqua
Attività: Farina di cereali
Proprietà: Privato
Info proprietà: Gestito dalla famiglia Ronci da oltre settant'anni
Stato: In funzione
Visitabile: Si
Ospitalità: No
Bibliografi: Morganti Luca, Semprini Mirco, 1999, "I Mulini della Valmarecchia", Editrice La Mandragora, Imola
Note storiche: Ultimo mulino funzionante degli oltre 165 mulini ad acqua della Valmarecchia, è composto da due macine per le farine, una segheria ed una centrale idroelettrica. Denominazioni precedenti: Molino Fattori (IGM 1895), Mulino Schieti (IGM 1937). Presente nella Carta Idrografica del 1889.
Molino Ronci Di Ronci Marcello E C. S.N.C.
Nome: Mulino Ronci
Regione: Emilia-Romagna
Provincia: Rimini
Comune: Pennabilli
Indirizzo: via Mulino Schieti, 23 Ponte Messa
Tipologia: Acqua
Attività: Farina di cereali
Proprietà: Privato
Info proprietà: Gestito dalla famiglia Ronci da oltre settant'anni
Stato: In funzione
Visitabile: Si
Ospitalità: No
Bibliografi: Morganti Luca, Semprini Mirco, 1999, "I Mulini della Valmarecchia", Editrice La Mandragora, Imola
Note storiche: Ultimo mulino funzionante degli oltre 165 mulini ad acqua della Valmarecchia, è composto da due macine per le farine, una segheria ed una centrale idroelettrica. Denominazioni precedenti: Molino Fattori (IGM 1895), Mulino Schieti (IGM 1937). Presente nella Carta Idrografica del 1889.
Nome: Mulino Sapignoli
Regione: Emilia-Romagna
Provincia: Rimini
Comune: Poggio Torriana
Indirizzo: Santarcangiolese Santo Marino
Tipologia: Acqua
Attività: Farina di cereali
Proprietà: Pubblico
Info proprietà: Comune di Poggio Torriana
Stato: Museo
Visitabile: Si
Ospitalità: No
Bibliografia: Luca Morganti Mirco Semprini, I MULINI DELLA VALMARECCHIA, Editrice La Mandragora, Imola 1999. Alessandro Serpieri, OPIFICI DELLA FOSSA VISERBA, in AA.VV., VISERBA...E VISERBA, Luisè Editore, Rimini, 1993. Mario Turci, I CINQUE MULINI DI POGGIO BERNI, in Pier Angelo Fontana (a cura di), POGGIO BERNI, NOTE PER UNA STORIA, Maggioli Editore, Rimini 1990
Note storiche: Già denominato M° Cenni (I.G.M. 1911), M° Tosi (I.G.M. 1894), M° detto del Palazzo (Cabreo 1793), è presente in documenti e nella cartografia storica a partire dal 1793 anche se, come tutti gli altri 20 mulini presenti sulla stessa fossa (fossa Viserba), ha origine intorno al XIV secolo.
Museo Mulino Sapignoli
4641 Via SantarcangioleseNome: Mulino Sapignoli
Regione: Emilia-Romagna
Provincia: Rimini
Comune: Poggio Torriana
Indirizzo: Santarcangiolese Santo Marino
Tipologia: Acqua
Attività: Farina di cereali
Proprietà: Pubblico
Info proprietà: Comune di Poggio Torriana
Stato: Museo
Visitabile: Si
Ospitalità: No
Bibliografia: Luca Morganti Mirco Semprini, I MULINI DELLA VALMARECCHIA, Editrice La Mandragora, Imola 1999. Alessandro Serpieri, OPIFICI DELLA FOSSA VISERBA, in AA.VV., VISERBA...E VISERBA, Luisè Editore, Rimini, 1993. Mario Turci, I CINQUE MULINI DI POGGIO BERNI, in Pier Angelo Fontana (a cura di), POGGIO BERNI, NOTE PER UNA STORIA, Maggioli Editore, Rimini 1990
Note storiche: Già denominato M° Cenni (I.G.M. 1911), M° Tosi (I.G.M. 1894), M° detto del Palazzo (Cabreo 1793), è presente in documenti e nella cartografia storica a partire dal 1793 anche se, come tutti gli altri 20 mulini presenti sulla stessa fossa (fossa Viserba), ha origine intorno al XIV secolo.
Sempre in Valmarecchia troviamo il mulino della Cooperativa Valmarecchia Bio Natura inaugurato in località Camparone a Ponte Messa di Pennabilli a gennaio del 2020. Le farine dei grani antichi della Cooperativa Valmarecchia Bio Natura sono già in utilizzo anche dalla Comunità di San Patrignano per la produzione di piadine e ‘grissinotti’.
Valmarecchia Bio Natura Soc. Coop. Agricola
Sempre in Valmarecchia troviamo il mulino della Cooperativa Valmarecchia Bio Natura inaugurato in località Camparone a Ponte Messa di Pennabilli a gennaio del 2020. Le farine dei grani antichi della Cooperativa Valmarecchia Bio Natura sono già in utilizzo anche dalla Comunità di San Patrignano per la produzione di piadine e ‘grissinotti’.
Mulino Calcagnini Fusignano
Il Mulino si trova all'incrocio del Canale dei Mulini con la via che da Fusignano conduce direttamente alla frazione Maiano Monti, un percorso antico, così come antiche sono le direttrici che servono il paese: la via Quarantola o del Mercato di Lugo, la via Cocorre e la via Del Porto che correndo a destra del canale lo collegava alle valli. In origine si trovava in posizione isolata, a circa 500 metri a ovest dell'abitato, oggi l'edificio viene a trovarsi sul limitare dell'agglomerato urbano. Da una attenta analisi della storiografia locale il Mulino sembra già esistere dalla prima metà del Trecento, alimentato dall'acqua che dal fiume Senio giungeva attraverso un caminello. La conferma ufficiale Oratorio dell'Angelo Custodedell'attività dell'opificio verrà data più tardi il 25 dicembre 1465, nell'atto di infeudazione di Fusignano al Conte Teofilo Calcagnini da parte di Borso d'Este. Alcuni preziosi rilievi del Mulino effettuati nel 1732 ne chiariscono la tecnologia consistente allora in una sola posta di macine collegate per traverso ed una ruota a pale. Nel corso degli anni il corpo di fabbrica ha subito inevitabili adeguamenti sia tecnologici che strutturali, nel 1770 nella lavorazione si utilizzano le ritrecine (motori idraulici) e le poste diventano due, nel 1883 vengono raddoppiate le poste ed installati altri due motori idraulici. Fra le innovazioni tecnologiche nel 1940 è documentata la presenza di una turbina idraulica, delle diverse macine una è ancora oggi al suo posto accoppiata ad un motore elettrico. La struttura realizzata nel 1740, e ancora oggi visibile addossata ai successivi corpi di fabbrica, consiste in un edificio a pianta quadrata su due piani e sottotetto, con copertura a quattro acque. Dall'apertura centrale del portico si accede agli altri locali del Mulino, fra i quali si distingue un vasto ambiente caratterizzato da grossi pilastri in muratura. Il primo piano, delle medesime dimensioni di quello terreno, era occupato dalla abitazione del mugnaio. Il sottotetto tutto adibito a granaio conserva ancora gli originari pilastri, mentre la struttura lignea del tetto è caratterizzata dalle originarie grosse capriate. Le vicende belliche hanno distrutto l'ala di ponente dell'edificio con il porticato risalente all'ottocento. Attualmente il Mulino ospita il laboratorio artigiano di oggetti in ferro battuto del proprietario Sig.Martini».
Fusignano Molino station
Mulino Calcagnini Fusignano
Il Mulino si trova all'incrocio del Canale dei Mulini con la via che da Fusignano conduce direttamente alla frazione Maiano Monti, un percorso antico, così come antiche sono le direttrici che servono il paese: la via Quarantola o del Mercato di Lugo, la via Cocorre e la via Del Porto che correndo a destra del canale lo collegava alle valli. In origine si trovava in posizione isolata, a circa 500 metri a ovest dell'abitato, oggi l'edificio viene a trovarsi sul limitare dell'agglomerato urbano. Da una attenta analisi della storiografia locale il Mulino sembra già esistere dalla prima metà del Trecento, alimentato dall'acqua che dal fiume Senio giungeva attraverso un caminello. La conferma ufficiale Oratorio dell'Angelo Custodedell'attività dell'opificio verrà data più tardi il 25 dicembre 1465, nell'atto di infeudazione di Fusignano al Conte Teofilo Calcagnini da parte di Borso d'Este. Alcuni preziosi rilievi del Mulino effettuati nel 1732 ne chiariscono la tecnologia consistente allora in una sola posta di macine collegate per traverso ed una ruota a pale. Nel corso degli anni il corpo di fabbrica ha subito inevitabili adeguamenti sia tecnologici che strutturali, nel 1770 nella lavorazione si utilizzano le ritrecine (motori idraulici) e le poste diventano due, nel 1883 vengono raddoppiate le poste ed installati altri due motori idraulici. Fra le innovazioni tecnologiche nel 1940 è documentata la presenza di una turbina idraulica, delle diverse macine una è ancora oggi al suo posto accoppiata ad un motore elettrico. La struttura realizzata nel 1740, e ancora oggi visibile addossata ai successivi corpi di fabbrica, consiste in un edificio a pianta quadrata su due piani e sottotetto, con copertura a quattro acque. Dall'apertura centrale del portico si accede agli altri locali del Mulino, fra i quali si distingue un vasto ambiente caratterizzato da grossi pilastri in muratura. Il primo piano, delle medesime dimensioni di quello terreno, era occupato dalla abitazione del mugnaio. Il sottotetto tutto adibito a granaio conserva ancora gli originari pilastri, mentre la struttura lignea del tetto è caratterizzata dalle originarie grosse capriate. Le vicende belliche hanno distrutto l'ala di ponente dell'edificio con il porticato risalente all'ottocento. Attualmente il Mulino ospita il laboratorio artigiano di oggetti in ferro battuto del proprietario Sig.Martini».
Lavatoi pubblici
L'antico lavatoio è ubicato nel borgo medioevale di Sant'Antonio, il quartiere meglio conservato e più suggestivo di Verucchio capoluogo. Il sito è raggiungibile sia in macchina che a piedi, ed è infatti una piacevole passeggiata nel borgo a condurre gli interessati alla scoperta dell'antico lavatoio verucchiese, ascrivibile al XVII secolo. All'inizio del Novecento sono stati svolti lavori di restauro sulla fonte e sulla vasca, l'ultimo restauro risale ai primi anni del 2000.
49 ντόπιοι το προτείνουν
Verucchio
L'antico lavatoio è ubicato nel borgo medioevale di Sant'Antonio, il quartiere meglio conservato e più suggestivo di Verucchio capoluogo. Il sito è raggiungibile sia in macchina che a piedi, ed è infatti una piacevole passeggiata nel borgo a condurre gli interessati alla scoperta dell'antico lavatoio verucchiese, ascrivibile al XVII secolo. All'inizio del Novecento sono stati svolti lavori di restauro sulla fonte e sulla vasca, l'ultimo restauro risale ai primi anni del 2000.
Il Lavatoio di Montepetra si incontra percorrendo l’itinerario n. 10, in un punto in cui il sentiero lascia la strada per volgere verso Montepetra alta.
Può essere considerato un “luogo della memoria”, punto di ritrovo d’altri tempi. Oltre ad essere opere indispensabili per la vita delle generazioni che ci hanno preceduto, i lavatoi erano infatti anche luoghi di socializzazione, di scambio di notizie e di chiacchiere.
Il Lavatoio di Montepetra è stato restaurato nel 2006. Attualmente, grazie anche alla piccola area di sosta adiacente, costituisce un punto di richiamo per i cicloturisti in cerca di ristoro e di suggestivi scenari naturalistici.
Lavatoio Montepetra Alta
Il Lavatoio di Montepetra si incontra percorrendo l’itinerario n. 10, in un punto in cui il sentiero lascia la strada per volgere verso Montepetra alta.
Può essere considerato un “luogo della memoria”, punto di ritrovo d’altri tempi. Oltre ad essere opere indispensabili per la vita delle generazioni che ci hanno preceduto, i lavatoi erano infatti anche luoghi di socializzazione, di scambio di notizie e di chiacchiere.
Il Lavatoio di Montepetra è stato restaurato nel 2006. Attualmente, grazie anche alla piccola area di sosta adiacente, costituisce un punto di richiamo per i cicloturisti in cerca di ristoro e di suggestivi scenari naturalistici.
La frazione di Taverna Comune di Montecolombo Montescudo conserva ancora oggi il suo vecchio lavatoio costruito nel 1874, situato lungo il corso del Rio Calamino da cui prende l’acqua. Dalla fontana del paese, si raggiunge scendendo una piccola scalinata che conduce sotto il livello stradale. Il lavatoio si presenta subito con un aspetto autentico: ha un’unica grande vasca – al contrario di quello di Monte Colombo ad esempio, che si trova a poche centinaia di metri -, la quale presenta bordi arrotondati e inclinati per lavare i panni, mentre dall’alto della parete in ciottoli e mattoni sgorga l’acqua. L’importanza di questo manufatto e dello stesso luogo in cui sorge (che insieme all’antico ponte ha rappresentato ufficialmente il confine tra Montescudo e Monte Colombo fino agli inizi del XX secolo) è testimoniata in tantissimi modi, non fosse altro perché era situato nel cuore dell’abitato ed era in grado di rifornire di acqua un grande numero di famiglie durante tutto l’anno. Di fatto, fino all’arrivo della rete idrica pubblica, è stato uno dei principali luoghi di aggregazione di Taverna, salvo poi cadere in disuso e venire via via abbandonato. Proprio per preservarne il ricordo, però, nel 2002 il lavatoio è stato restaurato ed è attualmente visitabile nonché funzionante, anche se ovviamente non viene più utilizzato per lavare alcunché.
Taverna
La frazione di Taverna Comune di Montecolombo Montescudo conserva ancora oggi il suo vecchio lavatoio costruito nel 1874, situato lungo il corso del Rio Calamino da cui prende l’acqua. Dalla fontana del paese, si raggiunge scendendo una piccola scalinata che conduce sotto il livello stradale. Il lavatoio si presenta subito con un aspetto autentico: ha un’unica grande vasca – al contrario di quello di Monte Colombo ad esempio, che si trova a poche centinaia di metri -, la quale presenta bordi arrotondati e inclinati per lavare i panni, mentre dall’alto della parete in ciottoli e mattoni sgorga l’acqua. L’importanza di questo manufatto e dello stesso luogo in cui sorge (che insieme all’antico ponte ha rappresentato ufficialmente il confine tra Montescudo e Monte Colombo fino agli inizi del XX secolo) è testimoniata in tantissimi modi, non fosse altro perché era situato nel cuore dell’abitato ed era in grado di rifornire di acqua un grande numero di famiglie durante tutto l’anno. Di fatto, fino all’arrivo della rete idrica pubblica, è stato uno dei principali luoghi di aggregazione di Taverna, salvo poi cadere in disuso e venire via via abbandonato. Proprio per preservarne il ricordo, però, nel 2002 il lavatoio è stato restaurato ed è attualmente visitabile nonché funzionante, anche se ovviamente non viene più utilizzato per lavare alcunché.
Due eventi in autunno per fare rivivere l’ex lavatoio. Così si torna a parlar di un progetto di recupero attraverso risorse dell’Unione Europea, dopo l’occasione “sprecata” una dozzina d’anni fa, quando un’impresa salernitana si aggiudicò i lavori, senza mai portarli a termine. Con la conseguenza che ancora oggi la struttura, edificata nel 1912 e ubicata in viale Cecchini, è inaccessibile Progettata dell’urbanista cesenate Amilcare Zavatti, vissuto dal 1869 al 1939, per l’epoca era di concezione avveniristica.
Insomma, la nuova strada per riqualificare il vecchio complesso del lavatoio pubblico potrebbe passare, ancora una volta, dai fondi Ue.
I precedenti tentativi di recupero edilizio del lavatoio, iniziati fin dal 2011, furono un disastro. Probabilmente il nuovo stanziamento previsto non basterà a sistemare, bonificare e rimediare ai danni che la ditta di Salerno fece. Tra l’altro, fu anche sottoposta serrate indagini da parte della guardia di finanza campana per presunte altre irregolarità. I lavori di allora furono finanziati con 1 milione di euro di fondi europei. In un primo tempo si ipotizzò che il 70% delle opere fossero state ultimate e quindi si provò a coinvolgere nuove imprese per ultimare il lavori. Ma non ci si riuscì, anche perché si accertò che gli infissi presentavano fessure e le grandi pareti invetriate erano fuori asse, non allineate, rimaste sollevate da terra. Insomma un gruviera di lavori non solo non ultimati ma mal fatti. In più, l’Ordine degli ingegneri di Forlì-Cesena nel 2015 sollevò rilievi critici sul criterio del massimo ribasso adottato nel bando e sull’incarico dato al coordinatore della sicurezza. Due tecnici furono rinviati a giudizio ma furono alla fine assolti.
80 ντόπιοι το προτείνουν
Cesenatico
Due eventi in autunno per fare rivivere l’ex lavatoio. Così si torna a parlar di un progetto di recupero attraverso risorse dell’Unione Europea, dopo l’occasione “sprecata” una dozzina d’anni fa, quando un’impresa salernitana si aggiudicò i lavori, senza mai portarli a termine. Con la conseguenza che ancora oggi la struttura, edificata nel 1912 e ubicata in viale Cecchini, è inaccessibile Progettata dell’urbanista cesenate Amilcare Zavatti, vissuto dal 1869 al 1939, per l’epoca era di concezione avveniristica.
Insomma, la nuova strada per riqualificare il vecchio complesso del lavatoio pubblico potrebbe passare, ancora una volta, dai fondi Ue.
I precedenti tentativi di recupero edilizio del lavatoio, iniziati fin dal 2011, furono un disastro. Probabilmente il nuovo stanziamento previsto non basterà a sistemare, bonificare e rimediare ai danni che la ditta di Salerno fece. Tra l’altro, fu anche sottoposta serrate indagini da parte della guardia di finanza campana per presunte altre irregolarità. I lavori di allora furono finanziati con 1 milione di euro di fondi europei. In un primo tempo si ipotizzò che il 70% delle opere fossero state ultimate e quindi si provò a coinvolgere nuove imprese per ultimare il lavori. Ma non ci si riuscì, anche perché si accertò che gli infissi presentavano fessure e le grandi pareti invetriate erano fuori asse, non allineate, rimaste sollevate da terra. Insomma un gruviera di lavori non solo non ultimati ma mal fatti. In più, l’Ordine degli ingegneri di Forlì-Cesena nel 2015 sollevò rilievi critici sul criterio del massimo ribasso adottato nel bando e sull’incarico dato al coordinatore della sicurezza. Due tecnici furono rinviati a giudizio ma furono alla fine assolti.
LAVATOIO DI SOGLIANO CAPOLUOGO
Collocato lungo la centrale via E. Ricci del Capoluogo, il lavatoio rappresenta un vero e proprio “luogo della memoria” e come tale permette di conoscere com’era la vita in un tempo che tutto considerato non è neanche troppo lontano; un tempo che la storiografia contemporanea tende a riscoprire e che costituisce la base e la radice della crescita collettiva della comunità soglianese.
Dall’area circostante il lavatoio, si può intraprendere un suggestivo percorso pedonale che – attraverso il “Parco della Pace” – conduce al centro storico di Sogliano
Sogliano al Rubicone
17 Via Camillo Benso Conte di CavourLAVATOIO DI SOGLIANO CAPOLUOGO
Collocato lungo la centrale via E. Ricci del Capoluogo, il lavatoio rappresenta un vero e proprio “luogo della memoria” e come tale permette di conoscere com’era la vita in un tempo che tutto considerato non è neanche troppo lontano; un tempo che la storiografia contemporanea tende a riscoprire e che costituisce la base e la radice della crescita collettiva della comunità soglianese.
Dall’area circostante il lavatoio, si può intraprendere un suggestivo percorso pedonale che – attraverso il “Parco della Pace” – conduce al centro storico di Sogliano
Lavatoio Rontagnano
Collocato lungo la provinciale che collega la frazione Montepetra Bassa a Perticara, il lavatoio costituisce un “luogo della memoria”, allo stesso modo di quello presente nel capoluogo. Oltre ad essere opere indispensabili alla vita delle generazioni che ci hanno preceduto, i lavatoi erano anche luoghi di ritrovo, di socializzazione, di scambio di notizie e chiacchiere. Attualmente, grazie anche alla piccola area di sosta adiacente, costituisce un punto di richiamo per brevi soste di cicloturisti in cerca di suggestivi scenari naturalistici.
Lavatoio Montepetra Alta
Collocato lungo la provinciale che collega la frazione Montepetra Bassa a Perticara, il lavatoio costituisce un “luogo della memoria”, allo stesso modo di quello presente nel capoluogo. Oltre ad essere opere indispensabili alla vita delle generazioni che ci hanno preceduto, i lavatoi erano anche luoghi di ritrovo, di socializzazione, di scambio di notizie e chiacchiere. Attualmente, grazie anche alla piccola area di sosta adiacente, costituisce un punto di richiamo per brevi soste di cicloturisti in cerca di suggestivi scenari naturalistici.
Lavatoio – Taverna
e lavadur
La frazione di Taverna conserva ancora oggi il suo vecchio lavatoio costruito nel 1874, situato lungo il corso del Rio Calamino da cui prende l’acqua. Dalla fontana del paese, si raggiunge scendendo una piccola scalinata che conduce sotto il livello stradale. Il lavatoio si presenta subito con un aspetto autentico: ha un’unica grande vasca – al contrario di quello di Monte Colombo ad esempio, che si trova a poche centinaia di metri -, la quale presenta bordi arrotondati e inclinati per lavare i panni, mentre dall’alto della parete in ciottoli e mattoni sgorga l’acqua. L’importanza di questo manufatto e dello stesso luogo in cui sorge (che insieme all’antico ponte ha rappresentato ufficialmente il confine tra Montescudo e Monte Colombo fino agli inizi del XX secolo) è testimoniata in tantissimi modi, non fosse altro perché era situato nel cuore dell’abitato ed era in grado di rifornire di acqua un grande numero di famiglie durante tutto l’anno. Di fatto, fino all’arrivo della rete idrica pubblica, è stato uno dei principali luoghi di aggregazione di Taverna, salvo poi cadere in disuso e venire via via abbandonato. Proprio per preservarne il ricordo, però, nel 2002 il lavatoio è stato restaurato ed è attualmente visitabile nonché funzionante, anche se ovviamente non viene più utilizzato per lavare alcunché.
Lavatoio di Taverna
505 Via IndipendenzaLavatoio – Taverna
e lavadur
La frazione di Taverna conserva ancora oggi il suo vecchio lavatoio costruito nel 1874, situato lungo il corso del Rio Calamino da cui prende l’acqua. Dalla fontana del paese, si raggiunge scendendo una piccola scalinata che conduce sotto il livello stradale. Il lavatoio si presenta subito con un aspetto autentico: ha un’unica grande vasca – al contrario di quello di Monte Colombo ad esempio, che si trova a poche centinaia di metri -, la quale presenta bordi arrotondati e inclinati per lavare i panni, mentre dall’alto della parete in ciottoli e mattoni sgorga l’acqua. L’importanza di questo manufatto e dello stesso luogo in cui sorge (che insieme all’antico ponte ha rappresentato ufficialmente il confine tra Montescudo e Monte Colombo fino agli inizi del XX secolo) è testimoniata in tantissimi modi, non fosse altro perché era situato nel cuore dell’abitato ed era in grado di rifornire di acqua un grande numero di famiglie durante tutto l’anno. Di fatto, fino all’arrivo della rete idrica pubblica, è stato uno dei principali luoghi di aggregazione di Taverna, salvo poi cadere in disuso e venire via via abbandonato. Proprio per preservarne il ricordo, però, nel 2002 il lavatoio è stato restaurato ed è attualmente visitabile nonché funzionante, anche se ovviamente non viene più utilizzato per lavare alcunché.
Lavatoio – Monte Colombo
e lavadur
Il lavatoio di Monte Colombo ha caratterizzato la vita della comunità locale per tantissimi anni, anzi, nel corso degli ultimi secoli, visto che è già citato nei registri comunali come esistente dal 1739, menzionata come “una fonte ubicata in località Il Cece presente da tempo immemorabile”. La costruzione di quell’epoca, si può notare, ha inglobato quella più antica, ma al di là della sua datazione certa, è sempre stato un manufatto importantissimo per gli abitanti del borgo di Monte Colombo e, soprattutto, dei nuclei familiari dislocati nel territorio circostante: era infatti questo lavatoio, ubicato nel verde tra campi coltivati e alberi ad alto fusto, il luogo principale in cui le donne potevano lavare i panni, senza doversi recare in pratica al fiume Conca, dopo l’attuale frazione di Taverna. Dal 1949 inizia la costruzione dell’acquedotto pubblico a Monte Colombo e, di fatto, viene sancito il graduale abbandono del lavatoio, sia come utilizzo che come luogo di aggregazione.
Il lavatoio è stato comunque oggetto di diversi interventi e si presenta ancora oggi con la sua caratteristica struttura “a trabocchi” in quanto le vasche di raccolta delle acque sono poste ad altezza decrescente. Il sito è tuttora visitabile ed è infatti facilmente raggiungibile percorrendo via Acquabona, una caratteristica strada selciata a gradoni di origine antichissima che congiunge le frazioni di Villa e Borgo, riscoperta solo nel 2004 grazie ad una ricerca sul Catasto Calindri con contestuale verifica tra le persone più anziane della zona, che avevano sentito sempre parlare di questa antica via di collegamento senza però averla mai vista. L’altro percorso per raggiungere il lavatoio parte dall’abitato di Ca’ Mini è la cosiddetta “via del lavatoio”, anche se è in effetti un sentiero naturalistico immerso nel verde.
Poco distante è presente anche l’antica fonte, che insieme al lavatoio rappresenta uno spaccato di vita rurale del passato.
Montescudo-Monte Colombo
Lavatoio – Monte Colombo
e lavadur
Il lavatoio di Monte Colombo ha caratterizzato la vita della comunità locale per tantissimi anni, anzi, nel corso degli ultimi secoli, visto che è già citato nei registri comunali come esistente dal 1739, menzionata come “una fonte ubicata in località Il Cece presente da tempo immemorabile”. La costruzione di quell’epoca, si può notare, ha inglobato quella più antica, ma al di là della sua datazione certa, è sempre stato un manufatto importantissimo per gli abitanti del borgo di Monte Colombo e, soprattutto, dei nuclei familiari dislocati nel territorio circostante: era infatti questo lavatoio, ubicato nel verde tra campi coltivati e alberi ad alto fusto, il luogo principale in cui le donne potevano lavare i panni, senza doversi recare in pratica al fiume Conca, dopo l’attuale frazione di Taverna. Dal 1949 inizia la costruzione dell’acquedotto pubblico a Monte Colombo e, di fatto, viene sancito il graduale abbandono del lavatoio, sia come utilizzo che come luogo di aggregazione.
Il lavatoio è stato comunque oggetto di diversi interventi e si presenta ancora oggi con la sua caratteristica struttura “a trabocchi” in quanto le vasche di raccolta delle acque sono poste ad altezza decrescente. Il sito è tuttora visitabile ed è infatti facilmente raggiungibile percorrendo via Acquabona, una caratteristica strada selciata a gradoni di origine antichissima che congiunge le frazioni di Villa e Borgo, riscoperta solo nel 2004 grazie ad una ricerca sul Catasto Calindri con contestuale verifica tra le persone più anziane della zona, che avevano sentito sempre parlare di questa antica via di collegamento senza però averla mai vista. L’altro percorso per raggiungere il lavatoio parte dall’abitato di Ca’ Mini è la cosiddetta “via del lavatoio”, anche se è in effetti un sentiero naturalistico immerso nel verde.
Poco distante è presente anche l’antica fonte, che insieme al lavatoio rappresenta uno spaccato di vita rurale del passato.
Lavatoio – Montescudo
e lavadur
Se per le donne il lavatoio era un luogo dove lavare panni e vestiti, ma anche per incontrarsi e scambiarsi informazioni, notizie e piccoli grandi segreti, per i ragazzi della zona era invece la loro piscina estiva. Questa duplice funzione del “bottaccio” di Montescudo è ancora molto famosa tra gli abitanti del luogo, che ricordano con affetto sia l’uso tradizionale di questo manufatto, sia quello più giocoso e meno “regolare”. Si narra che d’estate, infatti, i ragazzi sfruttassero la vasca come una vera e propria piscina, tanto che a qualcuno venne perfino in mente di posizionare un cartello all’ingresso dalla strada con le indicazioni. Ovviamente il cartello fu prontamente rimosso dalle autorità locali, ma il fatto resta, soprattutto nelle chiacchiere tra i residenti. Il lavatoio è protetto da un muro di contenimento in ciottoli, ha un’unica grande vasca con bordi inclinati e sul fianco sinistro è presente una piccola vasca in pietra rettangolare.
Più fantasiosa, ma sicuramente anch’essa con un fondo di verità, è la leggenda sulle proprietà curative dell’acqua che zampillava dalla fonte sotterranea del lavatoio. Sono diversi, infatti, i racconti su persone comuni e personaggi famosi della comunità che amavano rifornirsi di queste acque per berle e curare alcune specifiche patologie.
10 ντόπιοι το προτείνουν
Montescudo
Lavatoio – Montescudo
e lavadur
Se per le donne il lavatoio era un luogo dove lavare panni e vestiti, ma anche per incontrarsi e scambiarsi informazioni, notizie e piccoli grandi segreti, per i ragazzi della zona era invece la loro piscina estiva. Questa duplice funzione del “bottaccio” di Montescudo è ancora molto famosa tra gli abitanti del luogo, che ricordano con affetto sia l’uso tradizionale di questo manufatto, sia quello più giocoso e meno “regolare”. Si narra che d’estate, infatti, i ragazzi sfruttassero la vasca come una vera e propria piscina, tanto che a qualcuno venne perfino in mente di posizionare un cartello all’ingresso dalla strada con le indicazioni. Ovviamente il cartello fu prontamente rimosso dalle autorità locali, ma il fatto resta, soprattutto nelle chiacchiere tra i residenti. Il lavatoio è protetto da un muro di contenimento in ciottoli, ha un’unica grande vasca con bordi inclinati e sul fianco sinistro è presente una piccola vasca in pietra rettangolare.
Più fantasiosa, ma sicuramente anch’essa con un fondo di verità, è la leggenda sulle proprietà curative dell’acqua che zampillava dalla fonte sotterranea del lavatoio. Sono diversi, infatti, i racconti su persone comuni e personaggi famosi della comunità che amavano rifornirsi di queste acque per berle e curare alcune specifiche patologie.
Lavatoio (bottaccio) – Santa Maria del Piano
e lavadur
Difficile immaginare che sotto la strada principale che collega la frazione di Santa Maria del Piano al territorio marchigiano, sia stato costruito nel passato un manufatto importante come il “bottaccio”, il nome con cui gli abitanti della zona sono soliti chiamarlo. Ma esiste ancora oggi e lo si può scoprire percorrendo via Molino Genga, la continuazione di via Sant’Apollinare che costeggia il fianco sinistro dell’omonima Chiesa settecentesca, ovviamente continuando nel tratto non carrabile, fino a sotto la strada. Il “bottaccio” è ubicato infatti a metà strada tra il nucleo storico del borgo e una vecchia casa padronale, un tempo di proprietà della Curia, che si dice fosse la più antica di Santa Maria, oggi purtroppo abbandonata a una fine meno gloriosa. Tutta quest’area era chiamata in dialetto “podere d’la Curia” e comprendeva sia l’immobile che il lavatoio, il cui utilizzo fu concesso dall’allora parroco di Marazzano agli abitanti di Santa Maria del Piano probabilmente durante l’Ottocento.
A poca distanza scorre il fiume Conca e sull’argine restano sparute tracce del molino Genga, da cui la strada prende il nome.
Il “bottaccio” è una grande vasca a cui le donne che dovevano lavare i panni accedevano scendendo alcuni gradini, oggi per evitare cadute accidentali l’accesso invece è protetto da un muretto e da una recinzione. Quello che si vede, è però solo una parte del vecchio lavatoio, perché sotto alla terra che li ha coperti ci sono ancora i piani inclinati su cui lavare la biancheria. Nell’acqua trasparente del “bottaccio” non si lavano più i panni, ma oggi nuotano tranquilli alcuni pesci rossi che lo hanno trasformato nel loro acquario personale. A qualche metro di distanza è presente il vecchio pozzo, dove c’è la sorgente d’acqua disponibile tutto l’anno.
Santa Maria del Piano
Lavatoio (bottaccio) – Santa Maria del Piano
e lavadur
Difficile immaginare che sotto la strada principale che collega la frazione di Santa Maria del Piano al territorio marchigiano, sia stato costruito nel passato un manufatto importante come il “bottaccio”, il nome con cui gli abitanti della zona sono soliti chiamarlo. Ma esiste ancora oggi e lo si può scoprire percorrendo via Molino Genga, la continuazione di via Sant’Apollinare che costeggia il fianco sinistro dell’omonima Chiesa settecentesca, ovviamente continuando nel tratto non carrabile, fino a sotto la strada. Il “bottaccio” è ubicato infatti a metà strada tra il nucleo storico del borgo e una vecchia casa padronale, un tempo di proprietà della Curia, che si dice fosse la più antica di Santa Maria, oggi purtroppo abbandonata a una fine meno gloriosa. Tutta quest’area era chiamata in dialetto “podere d’la Curia” e comprendeva sia l’immobile che il lavatoio, il cui utilizzo fu concesso dall’allora parroco di Marazzano agli abitanti di Santa Maria del Piano probabilmente durante l’Ottocento.
A poca distanza scorre il fiume Conca e sull’argine restano sparute tracce del molino Genga, da cui la strada prende il nome.
Il “bottaccio” è una grande vasca a cui le donne che dovevano lavare i panni accedevano scendendo alcuni gradini, oggi per evitare cadute accidentali l’accesso invece è protetto da un muretto e da una recinzione. Quello che si vede, è però solo una parte del vecchio lavatoio, perché sotto alla terra che li ha coperti ci sono ancora i piani inclinati su cui lavare la biancheria. Nell’acqua trasparente del “bottaccio” non si lavano più i panni, ma oggi nuotano tranquilli alcuni pesci rossi che lo hanno trasformato nel loro acquario personale. A qualche metro di distanza è presente il vecchio pozzo, dove c’è la sorgente d’acqua disponibile tutto l’anno.
Lavatoio – Valliano
la fonta de Ciccun
La sorgente di Valliano è conosciuta da tutti gli abitanti della zona come “la fonte dei Cicconi”, nome che deriva dalla importante famiglia che possedeva questo appezzamento di terreno, in passato coltivato a ulivi, e che fece costruire il lavatoio composto da una grande vasca rettangolare con bordi inclinati e per questo utilizzabile su tutti i quattro lati.
E’ un manufatto molto basso che si trova a livello dei campi e ci si imbatte in esso, quasi per caso, passeggiando lungo il percorso escursionistico “Sentiero dei Musei”, che conduce attraverso una piacevole passeggiata tra ulivi e campi dal Santuario di Valliano alla Chiesa della Pace. Nonostante sia in disuso da anni, se si guarda con attenzione, però, si riesce ancora a scoprire che in uno dei lati verso monte c’è ancora lo zampillo dell’antica fonte, la stessa che un tempo riempiva la vasca centrale per permettere alle lavandaie di compiere le loro operazioni.
Via Valliano
Via VallianoLavatoio – Valliano
la fonta de Ciccun
La sorgente di Valliano è conosciuta da tutti gli abitanti della zona come “la fonte dei Cicconi”, nome che deriva dalla importante famiglia che possedeva questo appezzamento di terreno, in passato coltivato a ulivi, e che fece costruire il lavatoio composto da una grande vasca rettangolare con bordi inclinati e per questo utilizzabile su tutti i quattro lati.
E’ un manufatto molto basso che si trova a livello dei campi e ci si imbatte in esso, quasi per caso, passeggiando lungo il percorso escursionistico “Sentiero dei Musei”, che conduce attraverso una piacevole passeggiata tra ulivi e campi dal Santuario di Valliano alla Chiesa della Pace. Nonostante sia in disuso da anni, se si guarda con attenzione, però, si riesce ancora a scoprire che in uno dei lati verso monte c’è ancora lo zampillo dell’antica fonte, la stessa che un tempo riempiva la vasca centrale per permettere alle lavandaie di compiere le loro operazioni.
Conserve
Ghiacciaia – Montescudo
la cunsérva
L’antica ghiacciaia di Montescudo ha rappresentato nel corso dei secoli un punto di riferimento per gli abitanti del luogo e, soprattutto, per le attività economiche che attorno ad essa hanno gravitato fino al recente passato, prima che venisse soppiantata dalle moderne tecnologie. La sua storia parte infatti nell’epoca malatestiana, quando fu costruita per trasformare la neve raccolta durante l’inverno in ghiaccio da utilizzare nei mesi più caldi. Nonostante questi manufatti siano abbastanza comuni nella Valconca e anche nella Valmarecchia, la struttura e il procedimento stesso per creare il ghiaccio realizzati a Montescudo sono abbastanza originali: la neve, infatti, veniva raccolta e gettata in questi grandi contenitori scavati nella terra e ricoperta di mattoni e pietre, poi veniva ricoperta con uno strato di sfalci e veniva quindi pressata. Si trattava invero di un’operazione che coinvolgeva l’intera comunità, in particolare i bambini della zona, che si divertivano a saltarci sopra per compattare la neve. Nel corso degli anni, nonostante l’avvento delle moderne tecnologie, l’utilizzo della ghiacciaia montescudese non venne abbandonato del tutto, ma divenne sempre più simile a quello di una moderna cella frigorifera ad esempio per mantenere la carne macellata, come in effetti fu sfruttata fino a metà Novecento. E da quell’epoca che le venne affibbiato il nome popolare di “conserva”.
10 ντόπιοι το προτείνουν
Montescudo
Ghiacciaia – Montescudo
la cunsérva
L’antica ghiacciaia di Montescudo ha rappresentato nel corso dei secoli un punto di riferimento per gli abitanti del luogo e, soprattutto, per le attività economiche che attorno ad essa hanno gravitato fino al recente passato, prima che venisse soppiantata dalle moderne tecnologie. La sua storia parte infatti nell’epoca malatestiana, quando fu costruita per trasformare la neve raccolta durante l’inverno in ghiaccio da utilizzare nei mesi più caldi. Nonostante questi manufatti siano abbastanza comuni nella Valconca e anche nella Valmarecchia, la struttura e il procedimento stesso per creare il ghiaccio realizzati a Montescudo sono abbastanza originali: la neve, infatti, veniva raccolta e gettata in questi grandi contenitori scavati nella terra e ricoperta di mattoni e pietre, poi veniva ricoperta con uno strato di sfalci e veniva quindi pressata. Si trattava invero di un’operazione che coinvolgeva l’intera comunità, in particolare i bambini della zona, che si divertivano a saltarci sopra per compattare la neve. Nel corso degli anni, nonostante l’avvento delle moderne tecnologie, l’utilizzo della ghiacciaia montescudese non venne abbandonato del tutto, ma divenne sempre più simile a quello di una moderna cella frigorifera ad esempio per mantenere la carne macellata, come in effetti fu sfruttata fino a metà Novecento. E da quell’epoca che le venne affibbiato il nome popolare di “conserva”.
Uno dei luoghi più caratteristici di Cesenatico è la Piazzetta della Conserve, dove un importante intervento di recupero, avviato negli anni '80, ha permesso di mantenere con una certa fedeltà l'antico contesto urbanistico della piazza.
Conosciute sul litorale adriatico fin dal '500, i primi documenti che attestano la presenza delle conserve - chiamate anche ghiacciaie - a Cesenatico, risalgono al XVIII secolo. Si tratta di strutture di grande importanza per la vita economica dei centri marittimi della Civiltà Marinara dell'Adriatico, poichè erano destinate alla conservazione di derrate alimentari, in particolare il pesce.
Anche se rimane ancora oggi difficile risalire alla prima collocazione delle conserve di Cesenatico, abbiamo notizia di uno spostamento di tutte le ghiacciaie in un'area sabbiosa detta "il Monte", situata sul lato est del canale.
A testimoniare l'importanza del mercato del pesce come principale risorsa economica di Cesenatico, alla fine del XIX secolo si contano una ventina di conserve. Il loro sfruttamento si prolungò anche nel primo quarto del '900, finchè tra il 1929 e il 1930 l'impianto della prima fabbrica per la produzione di ghiaccio artificiale non determinò l'abbandono delle tradizionali ghiacciaie.
Le ghiacciaie o conserve di Cesenatico sono ampi e profondi invasi in muratura, scavati a pozzo, di forma tronco-conica, del diametro di 8 metri e della profondità di 5 o 6 metri. Fuoriescono dal livello del suolo con un parapetto circolare, sono protette da coperture costruite in mattoni ben isolate dall'esterno con strati di paglia, sabbia, tetto in legno e a volte provviste di doppie porte, per evitare l'ingresso di aria calda all'interno.
Il pesce o gli altri alimenti venivano disposti con cura all'interno delle conserve, alternati a strati di ghiaccio o neve pressata, garantendo la conservazione mediante congelamento, secondo un sistema più moderno rispetto alla tecnica della salatura. Il ghiaccio o la neve provenivano in genere dalle colline vicine o dalla zona appenninica, trasportato su carri e raccolti in apposite vasche o canali. Alcune conserve erano adibite anche alla raccolta del ghiaccio, permettendo ai pescatori di prelevarlo per portarlo sulle loro barche e servirsene per le cassette con il pesce appena pescato e messo in vendita.
Delle tre conserve oggi visibili a Cesenatico, una di esse è coperta.
La Piazzetta delle Conserve, anche per la sua posizione centrale nel centro storico di Cesenatico, oggi ha riaquistato un ruolo importante nella vita sociale, economica e turistica della località romagnola.
In continuità con l'antica tradizione commerciale, nella piazza delle conserve tutti i giorni, al mattino viene ospitato il Mercatino dei Produttori Agricoli con frutta e verdura proveniente dalle campagne dei dintorni.
Nel periodo estivo vi ha luogo il Mercatino delle Pulci, una manifestazione di artigianato artistico, antichità e modernariato, mentre durante i lunedì sera la piazza si trasforma in teatro ed è dedicata alla musica classica con i concerti dei Notturni alle Conserve.
Il periodo di Natale nella Piazzetta delle Conserve viene allestito un grande e suggestivo Presepe, con statue a grandezza naturale.
14 ντόπιοι το προτείνουν
Πιάτσα ντέλε Κόνσερβε
12 Piazza delle ConserveUno dei luoghi più caratteristici di Cesenatico è la Piazzetta della Conserve, dove un importante intervento di recupero, avviato negli anni '80, ha permesso di mantenere con una certa fedeltà l'antico contesto urbanistico della piazza.
Conosciute sul litorale adriatico fin dal '500, i primi documenti che attestano la presenza delle conserve - chiamate anche ghiacciaie - a Cesenatico, risalgono al XVIII secolo. Si tratta di strutture di grande importanza per la vita economica dei centri marittimi della Civiltà Marinara dell'Adriatico, poichè erano destinate alla conservazione di derrate alimentari, in particolare il pesce.
Anche se rimane ancora oggi difficile risalire alla prima collocazione delle conserve di Cesenatico, abbiamo notizia di uno spostamento di tutte le ghiacciaie in un'area sabbiosa detta "il Monte", situata sul lato est del canale.
A testimoniare l'importanza del mercato del pesce come principale risorsa economica di Cesenatico, alla fine del XIX secolo si contano una ventina di conserve. Il loro sfruttamento si prolungò anche nel primo quarto del '900, finchè tra il 1929 e il 1930 l'impianto della prima fabbrica per la produzione di ghiaccio artificiale non determinò l'abbandono delle tradizionali ghiacciaie.
Le ghiacciaie o conserve di Cesenatico sono ampi e profondi invasi in muratura, scavati a pozzo, di forma tronco-conica, del diametro di 8 metri e della profondità di 5 o 6 metri. Fuoriescono dal livello del suolo con un parapetto circolare, sono protette da coperture costruite in mattoni ben isolate dall'esterno con strati di paglia, sabbia, tetto in legno e a volte provviste di doppie porte, per evitare l'ingresso di aria calda all'interno.
Il pesce o gli altri alimenti venivano disposti con cura all'interno delle conserve, alternati a strati di ghiaccio o neve pressata, garantendo la conservazione mediante congelamento, secondo un sistema più moderno rispetto alla tecnica della salatura. Il ghiaccio o la neve provenivano in genere dalle colline vicine o dalla zona appenninica, trasportato su carri e raccolti in apposite vasche o canali. Alcune conserve erano adibite anche alla raccolta del ghiaccio, permettendo ai pescatori di prelevarlo per portarlo sulle loro barche e servirsene per le cassette con il pesce appena pescato e messo in vendita.
Delle tre conserve oggi visibili a Cesenatico, una di esse è coperta.
La Piazzetta delle Conserve, anche per la sua posizione centrale nel centro storico di Cesenatico, oggi ha riaquistato un ruolo importante nella vita sociale, economica e turistica della località romagnola.
In continuità con l'antica tradizione commerciale, nella piazza delle conserve tutti i giorni, al mattino viene ospitato il Mercatino dei Produttori Agricoli con frutta e verdura proveniente dalle campagne dei dintorni.
Nel periodo estivo vi ha luogo il Mercatino delle Pulci, una manifestazione di artigianato artistico, antichità e modernariato, mentre durante i lunedì sera la piazza si trasforma in teatro ed è dedicata alla musica classica con i concerti dei Notturni alle Conserve.
Il periodo di Natale nella Piazzetta delle Conserve viene allestito un grande e suggestivo Presepe, con statue a grandezza naturale.
Un salto all'indietro di quasi 500 anni, nella remota Montiano emersa dagli scavi archeologici coordinati dalla Soprintendenza nell'estate del 2012 e da giugno a ottobre del 2014.
Una collaborazione nata un po’ per caso, un po’ per necessità e diventata nel tempo fondamentale per ricostruire uno spaccato importante della vita di Montiano nel primo Rinascimento, tra il 1400 e il 1600.
Lungo le strade, via Cesare Battisti e via Roma, e sotto Piazza Garibaldi, i lavori di ripavimentazione del centro urbano hanno portato in luce non solo i resti di un antico sistema di raccolta e scolo delle acque bianche (già in uso nel XVI secolo) ma soprattutto numerosi granai “a fossa” di età moderna, quasi tutti databili tra la fine del 1400 e il 1500.
Queste "conserve" sono vere e proprie fosse a forma di campana, scavate nell’arenaria e profonde fino a quattro metri, rivestite sulle pareti da paglia o canniccio e utilizzate per conservare grano, orzo, avena, fave, mandorle, ceci e altro. Chiuse per lo più agli inizi del 1600, hanno restituito diverse ceramiche utilizzate sulle tavole come stoviglie e vasellame comune (piatti, ciotole, catini ecc). Delle dieci fosse censite, la maggior parte erano ancora in perfetto stato di conservazione
Montiano
Un salto all'indietro di quasi 500 anni, nella remota Montiano emersa dagli scavi archeologici coordinati dalla Soprintendenza nell'estate del 2012 e da giugno a ottobre del 2014.
Una collaborazione nata un po’ per caso, un po’ per necessità e diventata nel tempo fondamentale per ricostruire uno spaccato importante della vita di Montiano nel primo Rinascimento, tra il 1400 e il 1600.
Lungo le strade, via Cesare Battisti e via Roma, e sotto Piazza Garibaldi, i lavori di ripavimentazione del centro urbano hanno portato in luce non solo i resti di un antico sistema di raccolta e scolo delle acque bianche (già in uso nel XVI secolo) ma soprattutto numerosi granai “a fossa” di età moderna, quasi tutti databili tra la fine del 1400 e il 1500.
Queste "conserve" sono vere e proprie fosse a forma di campana, scavate nell’arenaria e profonde fino a quattro metri, rivestite sulle pareti da paglia o canniccio e utilizzate per conservare grano, orzo, avena, fave, mandorle, ceci e altro. Chiuse per lo più agli inizi del 1600, hanno restituito diverse ceramiche utilizzate sulle tavole come stoviglie e vasellame comune (piatti, ciotole, catini ecc). Delle dieci fosse censite, la maggior parte erano ancora in perfetto stato di conservazione
La Cerchia dei Malatesta
Le “Cerchia” dei Malatesta
Nella periferia di Cesena nelle frazioni delle Vigne di Sant’Egidio di Martorano, San Giorgio e San Martino troviamo cinque “via Cerchia” seguite dal rispettivo nome della frazione.
Ma cos’erano le “Cerchia”.
Tale denominazione è dovuta alla “cerchia” dei fossati fatti realizzare dai Malatesta per la bonifica dei terreni e per difendere la città dalle incursioni che provenivano dal lato mare. Quella di Sant’Egidio venne creata nel 1411. In un antico documento di quell’anno si legge “ A di 20 gennaro, el Ser Malatesta fo fare el fossado de la Cerchia a San Gilio”
A Sant’Egidio inoltre proprio all’incrocio fra via Cervese (l’antica via del sale) e via Cerchia, esisteva nello stesso periodo anche la torre di guardia probabilmente munita di ponte levatoio per oltrepassare “la Cerchia”.
Dopo il periodo Malatestiano con i resti di quella torre venne costruita, a qualche decina di metri, una chiesetta (nella foto) che rimase attiva fino agli anni ‘50, quando venne demolita a seguito dell’inaugurazione della nuova Chiesa. Al suo posto vi è ora una abitazione privata costruita su un leggero dosso dovuto, probabilmente, alle strutture murarie antiche. Una celletta votiva segnala, la sua originaria posizione.
Sull’originale campana di piccole dimensioni giunta fino a noi e conservata all’ingresso della chiesa attuale, il fregio sul bordo reca scritto “La villa de San Gili mea F.F. MDLVII “ (La gente di Sant’Egidio mi fece fondere nel 1557”).
42 ντόπιοι το προτείνουν
Cesena
Le “Cerchia” dei Malatesta
Nella periferia di Cesena nelle frazioni delle Vigne di Sant’Egidio di Martorano, San Giorgio e San Martino troviamo cinque “via Cerchia” seguite dal rispettivo nome della frazione.
Ma cos’erano le “Cerchia”.
Tale denominazione è dovuta alla “cerchia” dei fossati fatti realizzare dai Malatesta per la bonifica dei terreni e per difendere la città dalle incursioni che provenivano dal lato mare. Quella di Sant’Egidio venne creata nel 1411. In un antico documento di quell’anno si legge “ A di 20 gennaro, el Ser Malatesta fo fare el fossado de la Cerchia a San Gilio”
A Sant’Egidio inoltre proprio all’incrocio fra via Cervese (l’antica via del sale) e via Cerchia, esisteva nello stesso periodo anche la torre di guardia probabilmente munita di ponte levatoio per oltrepassare “la Cerchia”.
Dopo il periodo Malatestiano con i resti di quella torre venne costruita, a qualche decina di metri, una chiesetta (nella foto) che rimase attiva fino agli anni ‘50, quando venne demolita a seguito dell’inaugurazione della nuova Chiesa. Al suo posto vi è ora una abitazione privata costruita su un leggero dosso dovuto, probabilmente, alle strutture murarie antiche. Una celletta votiva segnala, la sua originaria posizione.
Sull’originale campana di piccole dimensioni giunta fino a noi e conservata all’ingresso della chiesa attuale, il fregio sul bordo reca scritto “La villa de San Gili mea F.F. MDLVII “ (La gente di Sant’Egidio mi fece fondere nel 1557”).
Le Marine della Romagna
IL PORTO
La vita a Cattolica ruota da sempre attorno alla propria tradizione marinaresca.
Le antiche case dei pescatori e il grande porto pieno di imbarcazioni colme di reti, lo raccontano ancora oggi.
Non a caso, Cattolica vanta una flotta dedicata alla pesca che comprende più di 100 imbarcazioni. Ecco allora il ritmo quotidiano scandito dalle barche che ogni giorno riportano a riva i tesori del mare per arricchire le tante ricette della gastronomia locale.
Ma ecco anche i cantieri navali dove nascono nuovi gioielli che uniscono la più moderna tecnologia alla tradizione, alla passione di chi ha fatto dell’andar per mare una ragione di vita.
CATTOLICA E LA SUA MARINA
Fiore all’occhiello dell’area portuale di Cattolica è sicuramente la nuova darsena.
Elegante, armoniosa, ospita oggi circa 200 navi di dimensioni abbastanza considerevoli. Oltre ad essere un’importante sede nautica dotata di svariati servizi per proprietari delle imbarcazioni (parcheggio, assistenza tecnica e all’ormeggio, carburante, servizi igienici e tanto altro) la Marina di Cattolica rappresenta un vero e proprio polo di attrazione turistica. Chi si accinge a organizzare una vacanza in Riviera, non sottovaluti quindi la possibilità di raggiungerla per mare: in tale modo ogni nave potrà attraccare in totale sicurezza.
Marina di Cattolica station
Via AntoniniIL PORTO
La vita a Cattolica ruota da sempre attorno alla propria tradizione marinaresca.
Le antiche case dei pescatori e il grande porto pieno di imbarcazioni colme di reti, lo raccontano ancora oggi.
Non a caso, Cattolica vanta una flotta dedicata alla pesca che comprende più di 100 imbarcazioni. Ecco allora il ritmo quotidiano scandito dalle barche che ogni giorno riportano a riva i tesori del mare per arricchire le tante ricette della gastronomia locale.
Ma ecco anche i cantieri navali dove nascono nuovi gioielli che uniscono la più moderna tecnologia alla tradizione, alla passione di chi ha fatto dell’andar per mare una ragione di vita.
CATTOLICA E LA SUA MARINA
Fiore all’occhiello dell’area portuale di Cattolica è sicuramente la nuova darsena.
Elegante, armoniosa, ospita oggi circa 200 navi di dimensioni abbastanza considerevoli. Oltre ad essere un’importante sede nautica dotata di svariati servizi per proprietari delle imbarcazioni (parcheggio, assistenza tecnica e all’ormeggio, carburante, servizi igienici e tanto altro) la Marina di Cattolica rappresenta un vero e proprio polo di attrazione turistica. Chi si accinge a organizzare una vacanza in Riviera, non sottovaluti quindi la possibilità di raggiungerla per mare: in tale modo ogni nave potrà attraccare in totale sicurezza.
Ravenna
Il porto turistico internazionale Marinara si sviluppa all'interno del porto di Ravenna, più precisamente tra la diga foranea sud e il molo sud del canale Baiona. E' in grado di offrire al diportista i più moderni servizi sia in mare che a terr
Porto Turistico 'Marinara'
11/r Via MarinaraRavenna
Il porto turistico internazionale Marinara si sviluppa all'interno del porto di Ravenna, più precisamente tra la diga foranea sud e il molo sud del canale Baiona. E' in grado di offrire al diportista i più moderni servizi sia in mare che a terr
Onda Marina
Il Porto Turistico di Cesenatico è uno dei porti turistici più belli e caratteristici del mediterraneo. Per accedere al Porto Turistico si risale il porto canale “Leonardesco” per circa 500 mt. dall’imboccatura e poi si vira a destra.
Situato a pochi passi sia dal centro storico che dalle spiagge, consente ai suoi ospiti di raggiungere a piedi, con facilità, le numerose incantevoli attrattive che Cesenatico offre per tutto il corso dell’anno. Il Porto Turistico inoltre ospita al proprio interno la sede del corso di laurea in acquacoltura del Polo universitario di Cesena dell’Università degli studi di Bologna.
Marina Cesenatico
5 Via Andrea DoriaOnda Marina
Il Porto Turistico di Cesenatico è uno dei porti turistici più belli e caratteristici del mediterraneo. Per accedere al Porto Turistico si risale il porto canale “Leonardesco” per circa 500 mt. dall’imboccatura e poi si vira a destra.
Situato a pochi passi sia dal centro storico che dalle spiagge, consente ai suoi ospiti di raggiungere a piedi, con facilità, le numerose incantevoli attrattive che Cesenatico offre per tutto il corso dell’anno. Il Porto Turistico inoltre ospita al proprio interno la sede del corso di laurea in acquacoltura del Polo universitario di Cesena dell’Università degli studi di Bologna.
Portoverde
Il Marina di Portoverde è composto da due darsene: una di forma ellittica con 5 pontili nel suo interno l'altra di recente costruzione subito a sud della prima. L'imboccatura è protetta da due moli paralleli di circa 40 m radicati alla spiaggia. ...
Portoverde Marina Resort
67 Via Lungo DarsenaPortoverde
Il Marina di Portoverde è composto da due darsene: una di forma ellittica con 5 pontili nel suo interno l'altra di recente costruzione subito a sud della prima. L'imboccatura è protetta da due moli paralleli di circa 40 m radicati alla spiaggia. ...
Lido degli Estensi
La darsena turistica Marina degli Estensi fa parte del complesso portuale di Porto Garibaldi; si sviluppa su uno specchio acqueo di 33.000 mq., ed è dotata di pontili galleggianti con finger o briccole.
RECEPTION di Marina degli Estensi - Porto Turistico
2 Via Fortuna MarisLido degli Estensi
La darsena turistica Marina degli Estensi fa parte del complesso portuale di Porto Garibaldi; si sviluppa su uno specchio acqueo di 33.000 mq., ed è dotata di pontili galleggianti con finger o briccole.
Rimini
Nello specchio acqueo ad ovest del molo di levante del porto di Rimini è nato il nuovo porto turistico Marina di Rimini. E' una darsena completamente banchinata con 7 pontili interni con acqua ed energia elettrica. Il marina offre tutti i servizi nec...
Marina di Rimini
80 Viale OrtigaraRimini
Nello specchio acqueo ad ovest del molo di levante del porto di Rimini è nato il nuovo porto turistico Marina di Rimini. E' una darsena completamente banchinata con 7 pontili interni con acqua ed energia elettrica. Il marina offre tutti i servizi nec...
Cervia
Il Marina di Cervia è situato sul lato NE della vecchia darsena; è un porto turistico privato riservato alle imbarcazioni da diporto, formato da una darsena nel cui interno si trovano 8 pontili.
Cantiere Nautico Servimar srl - Porto Turistico di Cervia-
43 Lungomare G. D'AnnunzioCervia
Il Marina di Cervia è situato sul lato NE della vecchia darsena; è un porto turistico privato riservato alle imbarcazioni da diporto, formato da una darsena nel cui interno si trovano 8 pontili.
Vallugola
Il Marina di Baia Vallugola è un porticciolo turistico privato situato a 5 km da Gabicce Mare. E' protetto da un molo frangiflutti e da un molo di sottoflutto: l'imboccatura è larga 20 m.
PortoVallugola
Strada della VallugolaVallugola
Il Marina di Baia Vallugola è un porticciolo turistico privato situato a 5 km da Gabicce Mare. E' protetto da un molo frangiflutti e da un molo di sottoflutto: l'imboccatura è larga 20 m.